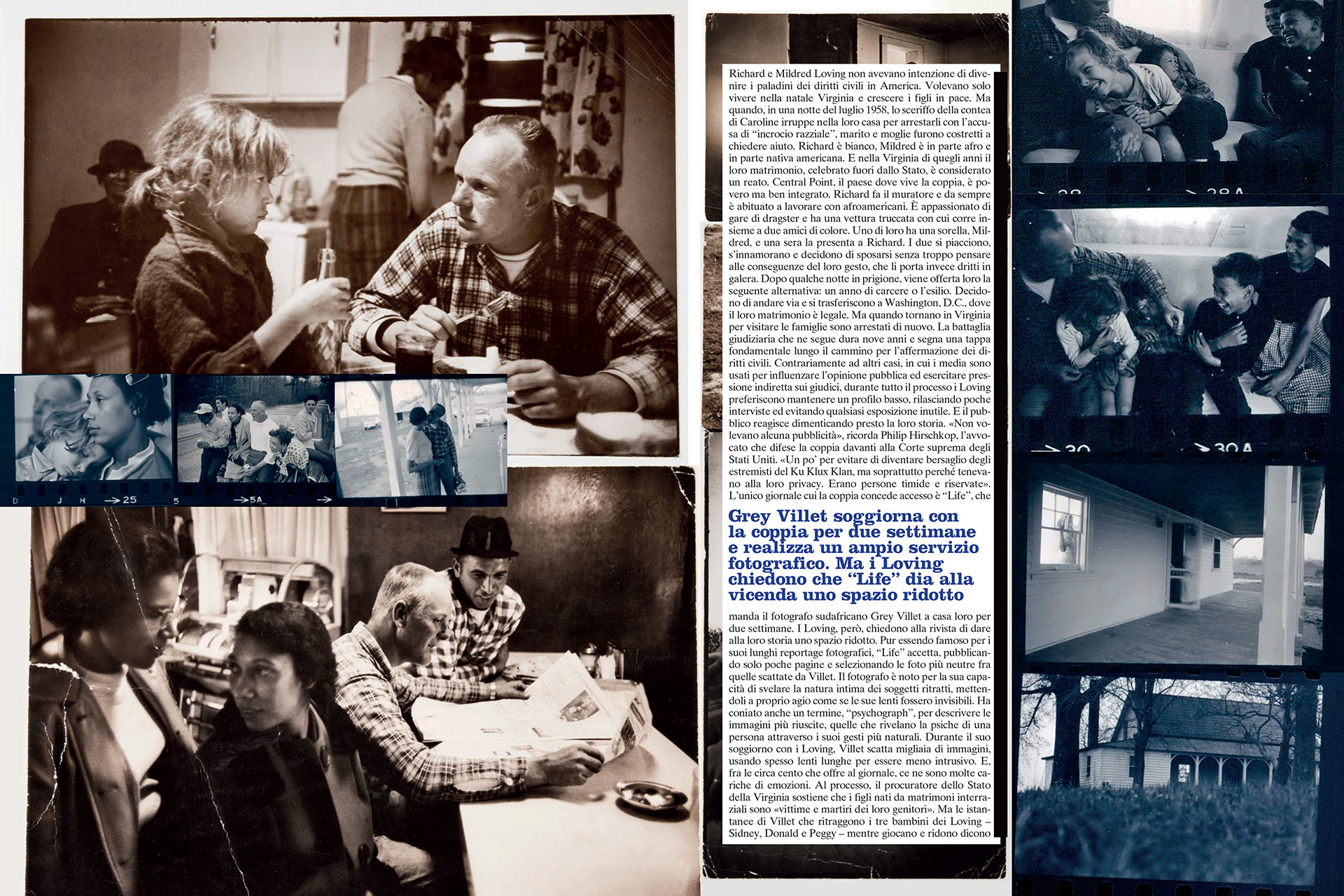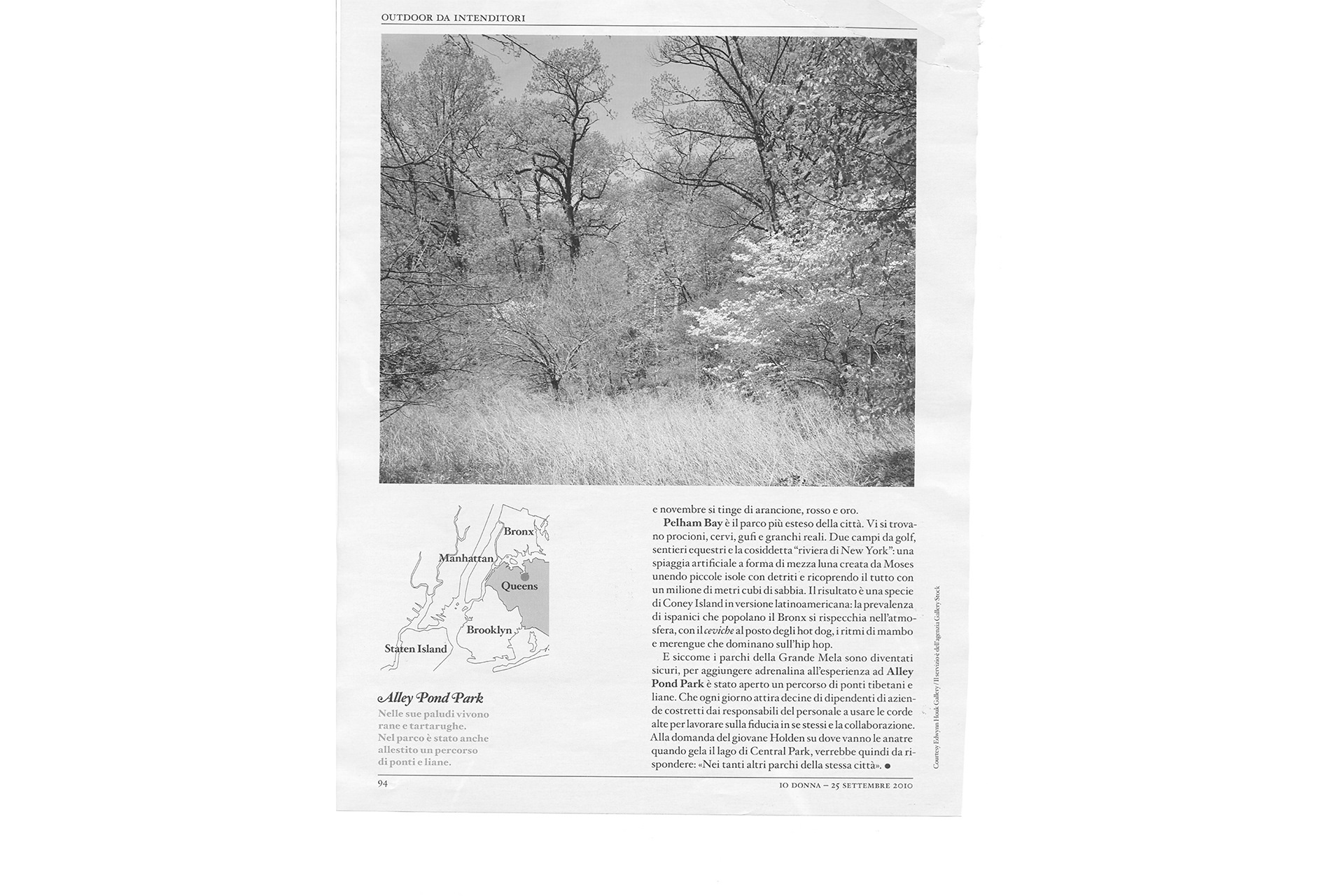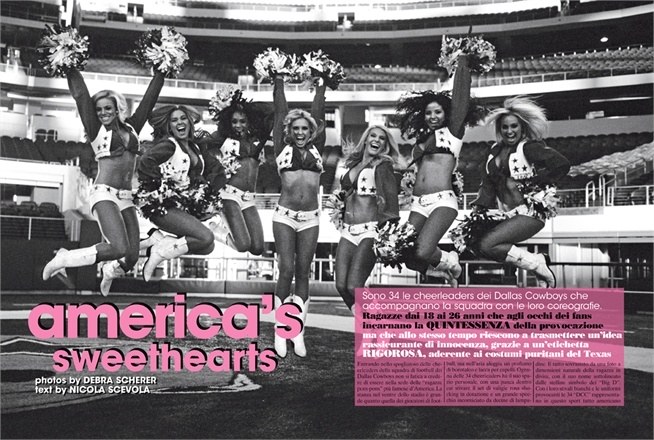Ski literature
for Rivista Undici
La letteratura che tratta di sci, neve e discese è fatta per la maggior parte di guide: tecniche, turistiche, fotografiche, manualistiche. Mentre dalla scena di Fantozzi sulle piste di Courmayeur alle innumerevoli sciate dell’agente Bond, gli sci hanno avuto svariate interpretazioni cinematografiche, non sono molti gli scrittori famosi che si sono confrontati con il Grande Bianco e il suo sport per eccellenza. Questo non vuol dire che manchino i libri interessanti. Significa solo che per trovare i titoli giusti bisogna allargare gli orizzonti e scavare un poco più a fondo, magari con l’aiuto di librai e bibliofili specializzati. “Non è facile scrivere bene di sci: occorre padroneggiare la materia e avere anche la capacità narrativa”, osserva Monica Garibaldi, titolare della libreria milanese Monti in Città, unica specializzata in questo genere letteratura insieme a La Montagna di Torino. “E poi mancano investimenti e attenzione da parte degli editori”. Oltre ad essere un genere di nicchia, c’è la questione che in Italia i testi sono pubblicati col contagocce e spesso spariscono poco dopo l’uscita. Alcuni titoli mitici come Alpinismo invernale, che racconta le prime esplorazioni in sci del pioniere svizzero Marcel Kurz, è addirittura introvabile. “Se fosse disponibile, l’avrei già venduto 30 volte” assicura Garibaldi. Romain Gary, uno degli autori francesi più prolifici del dopoguerra, due volte vincitore del premio Goncourt, negli anni Sessanta ha scritto un romanzo intitolato The ski bum che non è mai stato tradotto. “Per fare questo mestiere oltre a librai, bisogna essere un po’ bibliofili e aver voglia di ricercare”, conferma Maurizio Bovo della libreria La Montagna. La diffidenza dei grandi nomi dell’editoria verso un genere che non garantisce ritorni sicuri è comprensibile, ma lascia il mercato italiano nelle mani di piccoli editori, come Mulatero e Monterosa, che lavorano con passione e competenza ma non hanno le risorse per comprare diritti esteri e traduzioni.
La conseguenza è che, oggi, per leggere classici come Le skieur de l'impossible, sullo svizzero Sylvain Saudan, o Meine Spur, mein Leben, sul mitico spazzacamino di Merano Heini Holzen, occorre masticare il francese e il tedesco. Il primo, una biografia dell’antesignano dello sci ripido, si può ancora trovare in un’edizione italiana degli anni ’70 (Monti in Città ne ha una). Del secondo una traduzione uscirà, forse, solo il prossimo anno. “Il problema è che in Italia lo sci è vissuto solo come sport, trascurando l’aspetto culturale che sottende”, osserva Enrico Camanni, autore torinese e voce fra le più autorevoli di quelle che trattano il mondo alpino. Il romanziere ha scritto un giallo intitolato La Sciatrice in cui coniuga la storia di un soccorritore alpino che deve risolvere il mistero della scomparsa di una sciatrice in un crepaccio con riflessioni sulla montagna. “Manca ancora un fenomeno globale come Open di Agassi che dimostri le potenzialità di questo genere”. Eppure fra i pionieri della letteratura di sci e dintorni c’è proprio un italiano, primo connazionale a provare gli sci di fondo: il gesuita Francesco Negri (1623-1698), che a metà Seicento partì per il Polo Nord per capire come si vivesse a quelle latitudini. Nel suo Viaggio Settentrionale, il padre scrive che i cacciatori lapponi e svezzesi, come li chiama lui, si muovono veloci su “due tavolette sottili, che non eccedono in larghezza il piede, ma lunghe otto, o nove palmi con la punta alquanto rilevata per non intaccar la neve, nel mezzo di esse sono alcune funicelle, con le quali se le assettano bene una a un piede, e l’altra a l’altro, tenendo poi un bastone alla mano conficcato in una rotella perché non fori la neve”.
Di certo, lo stile di scrittura del gesuita ha fatto scuola. Ancora oggi, la letteratura di sci si confonde spesso con quella di viaggio. Fra gli autori italiani che hanno interpretato meglio questa tendenza c’è Giorgio Daidola, free rider patito di telemark, che nel suo Free Spirit riassume trent’anni di viaggi a caccia di fresca, dalle pareti degli 8000 metri tibetani ai raid nelle Rocky Mountains americane. Un libro di avventure, ma anche una riflessione sulla massificazione dell’esperienza alpina e un invito a sognare. Perché, come scrive Daidola, “finché si sogna c’è voglia di vivere, di conoscere, di scrivere. Finché si sogna c’è soprattutto voglia di sciare”. Il pantheon dello sci abbonda di eroi e campioni. Fra loro c’è Doug Coombs, padre dello sci estremo a stelle e strisce narrato in Sulle Tracce di Coomba attraverso i luoghi e le persone che l’hanno accompagnato fino alla tragica morte, avvenuta in Francia nel tentativo di soccorrere un amico precipitato in un dirupo. E Mario Cotelli, tecnico della nazionale italiana che in Valanga azzurra rievoca il periodo d’oro in cui la squadra riuscì in imprese impensabili. Le piste e i rifugi di montagna sono anche pieni di teste calde, oltre che pensanti. Fra queste Dick Dorworth autore di Night Driving che slalomeggia fra narrativa sciistica e psichedelica, in un racconto parte On the Road e parte Paura e disgusto a Las Vegas. L’autore, che negli anni ‘60 fu recordman di velocità a quasi 172 km/h, racconta i suoi viaggi sulle migliori piste americane alternando avventura, esperienze lisergiche e considerazioni filosofiche. Con taglio più sociologico, c’è White Planet tratteggia l’evoluzione della subcultura dei nomadi contemporanei che dedicano la vita a questo sport. I cosiddetti ski bum, malati di sci che si spostano a caccia di neve rimediando qualsiasi lavoro pur di vivere vicino agli impianti, un po’ come fanno i surfer con le onde. Qui si trovano le origini delle tendenze che più recentemente hanno cambiato il modo di vivere le nevi, come il freestyle. O che sono finite nel dimenticatoio, come lo ski ballet.
A testimoniare l’influenza profonda dello sci sulla storia delle nostre valli ci sono titoli come La leggenda dello sci alpino del giornalista Massimo Di Marco e La riscoperta delle Alpi con gli sci di Lorenzo Bersezio. Oppure libri che raccontano delle guerre combattute sulle nostre montagne: Il ghiacciaio di Nessuno di Marco Preti è un romanzo d’azione quasi cinematografico ( non a caso l’autore è anche regista), ispirato alle imprese dei Diavoli dell'Adamello durante la Prima Guerra Mondiale. La storia di alpini sciatori che hanno combattuto sul confine tra Austria e Italia accompagnati dalla costante presenza della Morte Bianca, del freddo e degli sci. Climb to Conquer è la storia vera di una divisione d’élite dell’esercito americano addestrata sui monti del Vermont e finita a combattere sugli Appennini. Oltre ad essere avvincente, il racconto, già opzionato da Robert Redford per un film, dimostra come il gesto e la disciplina dello sci abbiano forgiato menti brillanti: fra gli alpini americani c’erano il cofondatore della Nike Bill Bowerman, inventore di scarpe rivoluzionarie, e Bob Dole, senatore e candidato alla Casa Bianca ai tempi di Bill Clinton. Ma gli sci non sono solo eroismo e sacrificio. Per prendersi un po' meno sul serio c’è Anche le foche ridono, striscia a fumetti che scherza su vizi, nevrosi e manie di chi pratica lo scialpinismo firmata da Caio Comix, al secolo Claudio Getto. E per chi ama i rimandi ai temi d’attualità c’è Deep dell’americano Porter Fox, che analizza l’impatto dei cambiamenti climatici sul futuro di questo sport. Un ottimo richiamo per mettere a fuoco le conseguenze dei nostri comportamenti sugli ecosistemi montani e sulle nostre passioni.
Per confermare l’eclettismo del genere, è utile menzionare un ultimo titolo che, pur
trattandosi di un documentario, usa gli sci per parlare di uno dei mostri sacri della nostra
letteratura, innamorato di questo sport. Gli sci di Primo Levi, è un film di quest’anno della Rai
che segue il filo conduttore di un aneddoto narrato da Ives Francisco, falegname valdostano
arrestato dai fascisti il 13 dicembre ‘43 insieme a Levi sulle montagne della Val d’Ayas: il
racconto di un bel paio di sci abbandonati dallo scrittore ebreo in quell’occasione. Con i loro
attacchi Kandahar, con cavo a molla metallico e leva anteriore di serraggio per scivolare a
tallone libero o bloccare il piede, furono usati dal giovane falegname per riparare in Svizzera,
disertando la chiamata alle armi della Repubblica di Salò. E infine recuperati da Levi al suo
ritorno dai campi di concentramento.
© Nicola Scevola
The shape of water
for Vanity Fair Uomo
La curiosità di viaggiare controcorrente lungo il fiume Missouri nasce da un equivoco. Scoprire se è vero, come alcuni reclamano, che il Mississippi, fiume simbolo degli Stati Uniti, avrebbe in realtà dovuto chiamarsi Missouri. Quando due fiumi s’incontrano, solitamente è quello più grande a imporre il nome al corso d’acqua creato alla confluenza. Nel caso del Missouri e del Mississippi, invece, è successo il contrario, nonostante al loro incontro poco fuori St. Louis, il Missouri sia già ben più lungo del rivale. Oltre che da dubbi di natura geografica, il dibattito è alimentato da questioni d’importanza identitaria. I critici sostengono che il Missouri custodisca il mito fondante della nazione, quello dei pionieri e delle frontiere in continua espansione. Il fiume taglia il paese attraversando le Grandi Pianure del Midwest, le praterie delle riserve indiane fino ai ghiacciai del Montana, e ha rappresentato il perno della conquista del West. Fu lungo questo fiume che a inizio ‘800 fu organizzata l’esplorazione dei vasti territori che gli Stati Uniti acquistarono dalla Francia. Ma l’importanza di Big Muddy, com’è chiamato per via delle sue acque torbide, non è solo storica. Con le sue immense riserve naturali, la regione rurale che attraversa rappresenta l’alter ego dell’America urbana e liberale delle coste. Ci mettiamo alla guida di un fuoristrada per risalire i quasi 5000 km del suo corso ed esplorare questa terra che si potrebbe soprannominare Val Trumpia, per la spiccata tendenza repubblicana.
Il viaggio comincia fra distese infinite di soia e pannocchie. E’ il granaio che alimenta il più grande bistecchificio del mondo. In Kansas, Nebraska e Iowa si alleva quasi la metà della carne degli Stati Uniti. La prima, e forse unica, città che s’incontra dopo St. Louis è Kansas City, famosa per i locali jazz, il barbecue e le birre artigianali, simbolo del riscatto di una provincia sempre meno marginale. Risalendo più a nord arriviamo a Omaha, in Nebraska, con una piccola downtown fatta di saloon, empori ed ex depositi di mattoni ristrutturati. Ma non si creda che in questi posti si mangino solo hamburger e fagioli. “Anche nel regno della monocultura e dell’allevamento intensivo comincia ad affermarsi una sensibilità alimentare”, dice Tim Nicholson, chef del Boiler Room, ex centrale termica trasformata in ristorante. In questa terra definita “Monsanto-land” incontriamo un agricoltore che ci costringe a rivedere altri stereotipi. “Penso che sia arrivato il momento di pretendere valutazioni indipendenti sugli Ogm”, dice Scott Kinkaid, quarta generazione di farmer ad Hartington, che praticamente da solo coltiva l’equivalente di 4500 campi di calcio a soia e mais. “Sto diversificando e la mia produzione non-Ogm spesso è migliore, con sementi meno care. E Trump….è troppo spregiudicato, non ha la decenza del vero repubblicano”.
Continuando a nordovest, il fiume sembra scomparire lasciando spazio a un susseguirsi di grandi laghi. La parte settentrionale di Big Muddy racconta di un’occasione nata da un fallimento. Nel dopoguerra il governo pianificò un imponente sistema di dighe, dal Sud Dakota fino al Montana. L’idea era governare l’acqua per creare energia elettrica e irrigare i campi, riducendo il rischio di piene. Obiettivi più o meno falliti, che hanno però creato un’opportunità inaspettata: i laghi che oggi occupano un terzo del “nuovo Missouri” sono diventati mete per vacanzieri. E l’abbondanza del pregiato walleye, attira pescatori da tutto il mondo. “Il turismo è la seconda voce dopo l’agricoltura” conferma Karen Kern, direttrice del Sud Dakota Missouri River Tourism. Da Yancton, cittadina dallo charme western-retrò, la passione per la cultura di Toro Seduto e dei rituali pow wow ci porta a visitare le riserve indiane che si susseguono lungo il Missouri. Qui vediamo bisonti e cavalli al pascolo, e scopriamo che il mare di verde delle praterie ha tonalità infinite, soprattutto quando soffia il vento che cambia il colore dell’erba come un pennello che tira la vernice sulla tela.
Più a monte, il Missouri attraversa riserve naturali come le Badlands del Nord Dakota,
complesso di canyon rosa che s’incendiano alla luce del tramonto. O Great Falls in Montana, una
serie di 5 cascate dalla portata spettacolare. E’ anche la terra di villaggi come Zortman, ghost
town della corsa all’oro appollaiata a 1400 metri, quasi un borgo svizzero nel Far West: pini,
cowboy con i quad al posto dei cavalli, una prigione con 2 celle come sgabuzzini, una chiesetta
che domina la prateria sottostante. Alla fine, forse i sostenitori del “Grande Missouri” hanno
ragione: viaggiare lungo quest’arteria blu è una chiave per vivere l’identità americana come il
prodotto del susseguirsi di spostamenti. Quelli dei primi coloni europei; degli schiavi portati
dall’Africa; dei pionieri alla conquista dell’ovest; delle migliaia d’immigrati che costituiscono
la spina dorsale del paese. Un’identità che resta in continua evoluzione, come possono
testimoniare i cowboy del Montana che un tempo cacciarono gli indiani e oggi si sentono cacciati
a loro volta da un’organizzazione finanziata da imprenditori urbani che sta cercando di creare un
grande parco sui terreni usati per pascolare le mandrie. “Noi siamo quelli che si prendono cura
della terra”, dice Vicki Olson, allevatrice e titolare di un ranch da 8000 ettari. “La gente di
città è così lontana dalla vita rurale da non rendersi conto che senza pascoli spariscono anche
la carne e il latte”.
© Nicola Scevola
Il caporalato si batte allo sportello
for Pagina99
“Faccio la raccolta delle olive dal 2012 e ho sempre lavorato in nero”, dice Abram, bracciante senegalese di 49 anni impiegato nelle campagne della valle del Belice, il principale centro agricolo del trapanese. “Quest’anno la situazione è migliorata: per la prima volta ho un contratto, sono in regola e mi sento più sicuro”. A fine agosto a Castelvetrano ha aperto con successo uno “sportello per l’impiego”, primo tentativo in Italia di creare un luogo trasparente d’incontro tra domanda e offerta di lavoro per i migranti stagionali. La fornitura di manodopera è uno dei “servizi” principali offerti da caporali e sfruttatori di qualsiasi filiera, soprattutto quando c’è bisogno di tante braccia non specializzate in poco tempo, come in questo caso. Avere a disposizione un elenco di lavoratori extracomunitari in regola e pronti a farsi assumere è utile per le aziende agricole. E può segnare il confine fra la buona pratica e l’abuso. “Ho iscritto la mia azienda allo sportello perché ho sempre creduto che solo con la legalità questa terra possa togliersi il grande peso della mafia che porta sulle spalle”, dice Vincenzo Italia, titolare della ditta Terre in Fiore di Castelvetrano. Italia sottolinea che è anche merito della discreta redditività garantita delle olive locali se riesce a produrre nella legalità. “Ho convinto una quarantina di piccoli produttori come me a delegarmi la vendita delle loro olive, così posso spuntare prezzi migliori con i grossisti. Questo mi consente di rispettare le regole e di coltivare gli uliveti in modo dignitoso”.
Negli ultimi 20 anni, le olive della valle del Belice sono diventate la filiera trainante dell’agricoltura locale, con circa 16mila ettari di uliveti che producono 700/800mila quintali l’anno di olive da mensa e frantoio. Lo sviluppo di una rete idrica in campagna, fondamentale per la coltivazione, e la messa a punto di un trattamento a base di soda per addolcire questi frutti, ha reso la Nocellara del Belice un prodotto molto appetibile per il mercato italiano ed estero. Al punto che alla fine degli anni Novanta è stata creata una DOP, caso unico fra le olive da tavola, e gli uliveti hanno soppiantato la vite e gli agrumeti che un tempo dominavano il paesaggio locale. La raccolta della Nocellara, però, avviene ancora per la maggior parte a mano, senza l’aiuto di reti o abbacchiatori per non ammaccare i frutti. Questo ovviamente stimola la richiesta di manodopera che, a cavallo fra Ottobre e Novembre, è chiamata a raccogliere le olive della zona. Domanda che la popolazione locale, come in altre parti d’Italia, non è in grado di soddisfare. E che viene quindi appaltata alle centinaia di migranti che ogni anno si riversano nelle campagne di Castelvetrano, diventando facili prede di caporali e loschi mediatori. Un tempo provenivano dal Nord Africa, poi dalla Romania e oggi dall’Africa Occidentale, soprattutto da Senegal e Mali. “Castelvetrano è conosciuta in tutta Europa come un centro di sfruttamento del lavoro dei migranti”, ammette Giacoma Giacalone, segretaria della Flai CGIL di Trapani. Ma l’iniziativa di quest’anno, potrebbe cambiare questo stereotipo. Secondo l’ufficio provinciale del lavoro, durante la stagione di raccolta si sono iscritti allo sportello 850 lavoratori migranti e 208 aziende, che hanno provveduto all’assunzione regolare di 780 fra questi. “Quest’anno il fenomeno del caporalato è stato arginato”, dice Felice Crescente, direttore dell’ufficio del Lavoro. “I dati sono andati oltre le aspettative e suggeriscono che le aziende cominciano a capire che lo sfruttamento di manodopera al nero, soprattutto extracomunitaria, non paga”. Oltre a limitare il ruolo degli intermediari, lo sportello serve a mappare la situazione. “Avere dati certi su presenza ed esigenze di lavoratori e datori aiuta a gestire meglio il fenomeno”, aggiunge Crescente.
Certo, questa ventata di trasparenza non significa che la questione dello sfruttamento sia
risolta. Dalle interviste fatte a numerosi braccianti, risulta che la paga corrente per una
cassetta da 22/23 chili di olive sia tre euro. Questo significa che un lavoratore normale,
difficilmente porta a casa più di 40 euro al giorno, cifra ben al di sotto dei 62 euro del minimo
sindacale per un operaio a cottimo. Per non parlare della situazione degli alloggi. I migranti
che raccolgono le olive vivono perlopiù ammassati in un accampamento spontaneo sorto alla
periferia di Campobello, paese di 6000 abitanti nella campagna fra Castelvetrano e Mazzara del
Vallo. Sono circa 1500, con i più fortunati che dispongono di baracche in legno coperte di
plastica e tenute insieme da corda da pacchi. Mentre gli altri dormono in tende montate su pallet
appoggiati sulla terra battuta, che appena piove si trasforma in fanghiglia. Ci sono una dozzina
di bagni chimici che nessuno usa e docce improvvisate dove un secchio d’acqua riscaldata sul
fuoco costa 50 centesimi. Una manciata di rubinetti sparsi nel campo e un’unica capanna con un
allacciamento abusivo all’elettricità che per 5 euro offre la possibilità di ricaricare i
cellulari e di navigare su internet. Il protocollo d’intesa firmato da istituzioni, sindacati e
associazioni di produttori all’origine della creazione dello sportello di collocamento prevedeva
anche incentivi per migliorare la sistemazione dei lavoratori. Ma quest’anno non ha funzionato.
L’unico sito messo a disposizione dai Comuni è il parcheggio di un ex oleificio sequestrato alla
mafia: una colata di cemento per piantare le tende all’aperto, niente bagni e una tettoia per
cucinare, senza luce elettrica né acqua calda. Non stupisce che nessuno degli stagionali abbia
accettato di trasferirsi. “Il protocollo è ancora in una fase embrionale e, più che come un
traguardo, va inteso come la traccia di un percorso, che speriamo sia esportabile in tutta
Italia”, sottolinea Giacalone. “E’ un tentativo di fare emergere la legalità. E di seminare
l’idea che tutti possono trarne beneficio, non solo i lavoratori ma anche i cittadini che si
sentono invasi dal fenomeno delle migrazioni come se fosse altro rispetto alla ricchezza del
territorio”.
© Nicola Scevola
Salaam Italia
for Das Magazin
Am 3. Oktober 2013, kurz nach vier Uhr morgens, kenterte ein Kutter wenige Hundert Meter vor der Küste Lampedusas. Er war in der libyschen Hafenstadt Misrata losgefahren und schon seit zwei Tagen auf See, 500 Männer und Frauen, die meisten aus Somalia und Eritrea, als der Motor ausfiel und ein paar der Flüchtlinge ihre T-Shirts anzündeten, um die Küstenwache auf sich aufmerksam zu machen. Doch das Feuer geriet ausser Kontrolle, Panik brach aus, das Schiff begann zu sinken und riss einige mit in die Tiefe, andere schwammen oder hielten sich an den Leichen fest, die auf der Oberfläche trieben. Die Fischer Lampedusas wunderten sich über die gellenden Schreie der Möwen an jenem Morgen, der Wellengang war hoch, wie immer zu dieser Jahreszeit. Erst nach einer Weile bemerkten sie, dass es keine Vögel waren da draussen, sondern Menschen – und sie retteten 155 aus dem Wasser, über 300 starben. Taucher berichteten, sie hätten Kinderleichen auf dem Meeresgrund entdeckt. Der Arzt auf Lampedusa, Pietro Bartolo, sagte: «Ich habe noch nie solch eine menschliche Tragödie gesehen.» Die Bürgermeisterin Lampedusas, Giusi Nicolini, sagte: «Es ist furchtbar, einfach nur furchtbar.»
Angela Merkel sagte, sie sei tief bestürzt, und José Manuel Barroso, damals EU-Kommissionspräsident, schritt an den Särgen vorbei, die im Flughafenhangar der Insel aufgereiht waren, und sprach davon, wie er all diese Toten sein Lebtag nicht vergessen werde. «Es muss, muss, muss anders werden!», rief der italienische Innenminister Angelino Alfano beim selben Anblick, und Cecilia Malmström, damalige EU-Innen-kommissarin, sagte: «Das ist das Bild einer Union, die wir nicht wollen.» 366 Särge waren es am Ende, braune Kästen mit namen- losen Leichen, und die, welche überlebt hatten, kamen ins Flüchtlingslager nebenan. Sie erhielten neue Kleider, lagen auf ihren Matratzen, rauchten und hörten vielleicht, wie all die Politiker nach ein paar Tagen in ihren Helikoptern wieder davonflogen; der Journalistentross zog weiter, es wurde kalt auf Lampedusa, der Winter kam, als ein junger Mann beschloss, nach ihnen zu sehen. Aber Khalid Chaouki, frisch gewählter Abgeordneter des sozialdemokratischen Partito Democratico, der erste Muslim in Italiens Parlament, ein Junge aus Marokko, hatte nicht vor, nur Hände zu schütteln und nach ein paar Interviews wieder zu verschwinden. Chaouki nahm sich eine Matratze und legte sich neben sie. Er sprach ihre Sprache, nahm Notizen, machte Selfies von sich auf dem Bett, wie das 32-jährige Menschen heu- te eben tun, und stellte sie ins Netz. Er twitterte «buona notte da #lampedusa», schrieb auf seinem Smartphone Medienmitteilungen auf Italienisch und Englisch, in denen er den Alltag der Menschen beschrieb, den Schimmel in der Dusche, über- forderte Wärter, die den Insassen befehlen, sich draussen im Hof nackt auszuziehen, und sie mit Desinfektionsmittel gegen Krätze einsprühen. «Ich gehe erst, wenn sich das hier bessert», postete er auf Facebook – und Lampedusa war wieder zurück in den Schlagzeilen.
Giusi Nicolini, Bürgermeisterin dieses kleinen Stückchens Felsen, sprach daraufhin von KZ-ähnlichen Zuständen, weil die Menschen im Lager nur Nummern seien. Die BBC rief an. Italienische Politiker meldeten sich genervt aus ihren Weihnachtsferien und versprachen Besserung, und tatsächlich wurden die Flüchtlinge noch vor Ende des Jahres 2013 an einen anderen Ort verlegt mit Flugzeugen der Poste Italiane. Und er, Khalid Chaouki, geboren in Casablanca, wurde landes- weit bekannt. «Khalid for President», schrieb man ihm damals auf seine Facebook-Wall, und die Anzahl seiner Freunde und Follower wuchs im Minutentakt. «Chaouki, du Kebabfresser, du lebst nicht mehr lange», schrieben seine Gegner, und auch die formierten sich, mittlerweile erhält er mindestens eine Morddrohung pro Woche. Damals, Anfang 2014, rechnete er nicht damit, dass er ein Jahr später im Weissen Haus bei Präsident Obama zu Abend essen würde, weil er als Symbol für gelungene Integration junger Muslime in Europa gilt. Weil er einen Draht hat zu den jungen Einwanderern aus Afrika und ihre Geschichten kennt. Womit er aber immer rechnete, waren neue Schiffsunglücke, schlimmere als jenes im Oktober 2013. Neue Schreie er- trinkender Männer und Frauen, die tönen wie Möwen, neue Kinderleichen auf dem Meeresgrund, wie jetzt wieder im April.
Eineinhalb Jahre sind zwischen den beiden Tragödien vergangen, mehr als 5000 Flüchtlinge starben seitdem auf ihrer Reise übers Meer. Politiker haben Reden gehalten, Prominente Geld gesammelt, der Papst hat für die Toten gebetet, und Chaouki war jeden Tag unterwegs, in Lagern und Problem- vierteln, auf den Schiffen der italienischen Marine, die für die Operation Mare Nostrum Flüchtlinge in Seenot aufgriffen. Er war auf Gemüseplantagen im ganzen Land, dort, wo einige der jungen Afghanen und Syrer, Bangladesher und Inder landen, wenn sie mal Arbeit finden, wobei man von Arbeit nicht reden kann, denn sie werden gehalten wie Tiere. Hat sich sein Einsatz gelohnt? Hat sich irgendwas zum Besseren verändert? Stille. Khalid Chaouki ist in Strassburg an einem Parlamentariertreffen, Angela Merkel spricht mit Matteo Renzi, David Cameron hat seinen Wahlkampf unterbrochen, die ganze politische Klasse Europas tagt in irgendwelchen Zimmern. Es ist Ende April 2015, vier Tage sind vergangen, seit 800 Menschen vor Lampedusa starben. Chaouki schweigt und sagt schliesslich: «Nein. Natürlich nicht.» Betrachte man die Zahlen, dann habe sich gar nichts verbessert, im Gegenteil. Nur der Druck sei grösser, endlich etwas tun zu müssen. Lampedusa habe bis vor kurzem kaum jemanden interessiert, «nun geht es um die Würde Europas. Wir müssen Lösungen präsentieren.» Und die wären?
Wie in Guantánamo
Ein Jahr zuvor, an einem wolkenlosen Tag, steuert Khalid Chaouki seinen grauen Fiat Freemont
durch den dichten Ver- kehr Roms. Er telefoniert, schreibt ein paar SMS, checkt sein
Twitter-Konto, während er nebenbei erklärt, was in der euro- päischen Flüchtlingspolitik alles
schiefläuft. Chaouki ist auf dem Weg nach Ponte Galeria in ein sogenanntes
Identifikationszentrum. Es befindet sich ausserhalb der Stadt, eingefasst von schmutzigen
Feldern, und erinnert von weitem an die Gefangenenlager Guantánamos: Hohe Zäune mit Stacheldraht
umgeben das Gelände, Wachtürme an jeder Ecke, Innenhöfe ohne Schatten. Hierher kommt, wer auf
einem der Schiffe aus Afrika unterwegs nach Europa von der Polizei festgenommen wurde, wer keine
Papiere hat, weil er sie wegschmiss. Es gibt in ganz Italien 13 dieser Zentren, doch Ponte Gale-
ria hat einen besonders schlechten Ruf. Mehrmals haben sich Migranten ihre Münder zugenäht, um
gegen die unmenschlichen Bedingungen zu protestieren. Sie zogen kleine Metallstäbe aus ihren
Feuerzeugen, rissen Fäden aus ihren Laken und stachen sie sich in die Lippen. Chaouki ist nicht
zum ersten Mal hier. Gemeinsam mit Juristen vermittelt er zwischen Migranten und der Polizei und
konnte in kurzer Zeit einiges bewirken: Hunde werden nicht mehr eingesetzt, um Druck auf die
Insassen auszuüben. Die Beratung habe sich verbessert, heisst es aus NGO-Kreisen, es komme zu
regelmässigen Treffen mit den Botschaften. Kurz vor dem Eingangstor des Lagers bleibt Chaouki
stehen, steigt aus und beginnt mit einem jungen Senegalesen zu sprechen, der am Strassenrand
wartet. «Die Polizei hat mich erwischt, als ich Taschen in Roms Gassen verkaufte», sagt der Mann.
Er hatte kein Visum und keinen Pass, also brachte man ihn nach Ponte Galeria und liess ihn heute
frei, «nach drei Monaten», weil keiner wusste, was man mit ihm soll. So wie dem Senegalesen geht
es den meisten hier. Sie werden aufgegriffen, enden auf irgendwelchen Stockbetten, wo sie bis zu
sechs Monate verbringen, unterschreiben Formulare, die sie nicht verstehen, und werden wieder vor
die Tür gesetzt. «Was wirst du jetzt tun?», fragt Chaouki. «Keiner da, der dich holt?» Der
Senegalese schüttelt den Kopf: «Wer denn?»
Der Geschichtensammler
Es ist früher Nachmittag. Um diese Uhrzeit dürfen sich alle in den Innenhöfen frei bewegen, ein
langer Korridor umgeben von sechs Meter hohen Gittern, keine Bäume, keine Bänke, Flugzeuge vom
nahen Flughafen Fiumicino donnern über die Köpfe der meist jungen Männer, die hier draussen
stehen und rauchen. Als sie Chaouki sehen, kommen sie auf ihn zu. Einige kennen ihn und schütteln
seine Hand, andere nähern sich ihm langsam und erzählen ihm zögerlich ihre Geschichte: von der
Überfahrt, der Polizei, ihren Familien zu Hause. Chaouki schreibt sich ihre Namen auf, macht
Notizen, aber vor allem hört er ihnen zu, zwei, drei Stunden lang. Er war Journalist, bevor er
Abgeordneter der Sozialdemokraten wurde, das sieht man, und er wird die einzelnen
Lebensgeschichten, die er sich notiert hat, später mit Juristen durchgehen und schauen, was sich
machen lässt. Dann steigt er wieder in sein Auto, auf dessen Rückbank sich zwei Kindersitze
befinden. Vor dem Eingangstor sucht er nach dem Senegalesen, den er angesprochen hatte, doch der
ist weg, verschwunden in einem der anonymen Wohnhäuser am Stadtrand Roms. Er wird in ein paar
Tagen wieder Taschen verkaufen in Trastevere oder Sonnenbrillen auf dem Campo dei Fiori, wer
weiss das schon; einer dieser Schwarzen halt, an denen die Touristen, die das ganze Jahr über die
Innenstadt verstopfen, vorbeiziehen, als existierten sie nicht. Chaouki braust wieder zurück in
die Stadt, er hat Dutzende von Nachrichten auf seinem Telefon, das er wie ein Süchtiger einmal
pro Minute in die Hände nimmt. Er ist spät dran. Er wollte doch seiner Frau helfen, wollte mit
seinen Söhnen spie- len, Adam und Ilias, fünfund dreijährig, doch jetzt steckt er im Stau, nichts
geht mehr, weder vorwärts noch rückwärts; für jemanden, der so rastlos ist wie er, ist der
Abendverkehr Roms die Höchststrafe.
«Geh zurück zu deinen Ziegen»
1992 kamen Khalids Eltern von Marokko nach Italien und lebten in einer Einzimmerwohnung ohne
Heizung in Reggio Emilia. Sie besassen einen Kebabstand, der aber nicht gut lief, und weil
Italien in der Krise ist und es keine Arbeit gibt, zogen sie weiter an den Stadtrand von
Charleroi, belgische Öde, kurz nachdem ihr Sohn Khalid 2013 jüngstes Parlamentsmitglied wurde.
Chaouki spricht nicht gern über seine Eltern, sagt nur, dass es vielen so gehe wie ihnen, die
Zahl der Migranten in Italien nehme in Wirklichkeit ab. Auch wenn alle das Gegenteil behaupten.
«Zwar steigt auch hier die Angst vor Überfremdung, wie überall in Europa, dabei ziehen viele der
Flüchtlinge weiter in den Norden», nach England, nach Skandinavien, weil sie keine Arbeit finden.
Im Unterschied etwa zu Holland, Deutschland oder der Schweiz hat Italien keine Erfahrung mit
Einwanderern. Noch vor Jahren gab es kaum Menschen mit ausländischem Hintergrund in höheren
Ämtern, keine Ärzte, keine Lehrer, und so ist Chaoukis Generation der heute 30-Jährigen die
erste, die in der italienischen Gesellschaft angekommen ist. «Ich bin ein neuer Italiener»,
beantwortet er die Frage nach seiner Identität, stolz auf seinen italienischen Pass und seine
marokkanischen Wurzeln, ein Muslim im Zentrum der christlichen Welt. «Salaam Italia» heisst sein
erstes Buch, in dem er aufgeschrieben hat, wie so ein Leben geht zwischen den Kulturen und
Religionen. «Ich bin ein Symbol dafür, dass man es schaffen kann», sagt er selbstbewusst, und es
gibt viele, denen es bei solchen Sätzen Schaum vor den Mund treibt: «Geh zurück zu den Ziegen, wo
du herkommst», schreiben sie ihm auf seine Facebook- Seite, «du hast hier nichts verloren, und
nimm die Zigeuner gleich mit.»
«Natürlich verstehe ich die Angst vieler Italiener», sagt er und hupt und flucht über den Verkehr
wie ein echter Römer. «Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Wir haben grosse soziale Probleme in den
Aussenbezirken.» Diese Angst aber lasse sich abbau- en, dafür brauche es Zeit, blanker Rassismus
allerdings sei das andere, der sei hartnäckig und tief verwurzelt. Bereits als Kind habe er damit
Erfahrungen gemacht. Er war der einzige Ausländer seiner Klasse in einem Dorf in der Nähe Parmas.
Als ein Re- genschirm verloren ging, hat man natürlich ihn bezichtigt, den kleinen Marokkaner,
«marocchino bastardo». Und Jahre später, 2001, als Präsident der Jungen Italienischen Muslime,
wurde er nach den Anschlägen auf die Twin Towers in New York als Radikaler verunglimpft – dabei
ist das Gegenteil der Fall. «Khalid war der Erste, der sich für einen italienischen Islam
starkmachte», sagt Adil El Marouakhi, Direktor eines interkulturellen Zentrums in Reggio Emilia
und Khalids langjähriger Freund. «Er proklamierte einen neuen, einen progressiven Islam, der
weniger geprägt sei von der arabischen Kultur, und viele der Jungen, die ihm zuhörten, konnten
sich damit identifizieren.» Nach der zweistündigen Fahrt von Ponte Galeria ist Chaouki endlich in
der Nähe seiner Wohnung, keine zehn Minuten vom Bahnhof Termini entfernt. Er stellt den Wagen ab
und eilt zur Piazza Vittorio, wo seine Söhne auf ihn warten. «Papa», rufen sie von weitem, und er
rennt ihnen entgegen.
Auf den Schiffen der Marine
Vier Monate später, Oktober 2014, steht Chaouki in der grossen Halle des Flughafens Catania. Er
hat ein paar Parlamentarier eingeladen, gemeinsam wollen sie sich ein Bild machen von der
Operation Mare Nostrum, einer humanitären Mission, die am 18. Oktober 2013 startete, kurz nach
der Lampedusa-Tragödie: Fünf Marineschiffe, begleitet von vier Helikoptern, drei Flugzeugen und
zwei Drohnen halten Ausschau nach Menschen in Not, bis zu 90 Seemeilen von der italienischen
Küste entfernt. Doch schon jetzt, nach einem Jahr, soll Mare Nostrum eingestellt und durch die
Operation Triton ersetzt werden, weil das alles viel zu teuer sei, 9 Millionen Euro im Monat.
Ausser- dem würde ein Anreiz geschaffen, so sagt es Deutschlands Innenminister Thomas de
Maizière: Noch mehr Menschen würden versuchen, übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen, jetzt,
da die Marine Notleidenden hilft. Chaouki sieht das anders. «Menschen fliehen in Nussschalen
übers Mittelmeer, weil sie keine Zukunft mehr haben. Sie kommen sowieso, ob sie nun aufgelesen
werden oder nicht», sagt er, umringt von seinen Politikerkollegen. Deshalb ist er gekommen, um
für Mare Nostrum zu werben. Gemeinsam folgen sie einem Marineoffizier in blütenweisser Uniform in
einen Bus, der sie zu zwei grauen Helikoptern führt.
40 Minuten dauert der Flug übers Meer bis auf das Deck der San Giusto, ein 136 Meter langes
Schiff der italienischen Marine, in dessen Bauch sich Hunderte von Flüchtlingen befinden, die
aufgelesen wurden, kurz bevor sie ertrunken wären. Khalid Chaouki und seine Parlamentarier, alles
Männer, die sich ein wenig fühlen wie auf einem Abenteuerurlaub, wer- den auf der San Giusto von
Kapitän Mario Mattesi begrüsst und von Admiral Massimo Vianello, der für die Koordination der
gesamten Operation Mare Nostrum verantwortlich ist – zwei Männer, die vielleicht mehr über das
Flüchtlingsdesaster der letzten Jahre wissen als alle anderen, weil sie täglich die Leichen im
Wasser einsammeln, als wären es PET-Flaschen, und in die Gesichter sehen von denen, die es eben
noch geschafft haben. Die Offiziere bringen die Politiker in einen fensterlosen Konferenzraum mit
Neonlicht an der Decke und beginnen ihre Powerpoint-Präsentation, kurze, militärische Sätze,
jedes Wort ein Treffer: Sieben Schiffe voller Flüchtlinge sind täglich Richtung Italien
unterwegs. Im Sommer mehr als im Winter.
Die meisten starten von El Zuwara oder El Garabulli in
Westlibyen. Andere von Ägypten. Selten von Tunesien. Flüchtlinge aus Zuwara reisen in der Regel
in Holzbooten, während die aus Garabulli Schlauchboote benutzen, die in China hergestellt werden
und bei den ersten Wellen kentern. Migranten aus Ägypten kommen auf alten Fischer- booten.
Menschen flüchten, weil sie in ihren Herkunftsländern verfolgt werden oder weil sie keine
Zukunftsperspektive haben. Die Kritik an Mare Nostrum, die Operation ziehe Flüchtlinge an, ist
falsch. Die meisten Migranten sind männlich, meist unter 45, der Frauenanteil liegt bei 10
Prozent, Jugendliche sind selten, kommen aber vor. Kleinkinder ebenso.
Seit dem Start der
Operation Mare Nostrum wurden 330 Menschenhändler festgenommen.
Noch Fragen?
Ein Land ohne Bomben
Chaouki wippt mit den Füssen, wie ein Schüler, der bereits al- les weiss und nicht warten kann,
bis es weitergeht. Eine Stunde schon dauert die Präsentation, telefonieren kann er nicht, sein
iPad muss in der Tasche bleiben, er will zu den Migranten, deshalb ist er gekommen. Endlich
verteilt ein Arzt des Gesundheitsministeriums Ganzkörperanzüge, Masken und Handschuhe und führt
die Gruppe von Männern, die aussehen wie Ärzte im Ebola-Gebiet, in eine Halle von der Grösse
eines Fussballfeldes, in der sich die Flüchtlinge befinden. Sie sitzen am Boden, eng beieinander,
ohne Matratzen, keine Kissen. Manche haben sich Nummern auf die Hosen geschrieben, damit man ihre
Verwandten anrufen kann, falls man sie tot aus dem Wasser zieht. Es gibt drei Toiletten, eine
Ecke für medizinische Notfälle, einen Isolationsraum für Menschen mit ansteckenden Krankheiten
und ein Abteil für Frauen und Kleinkinder, getrennt nur durch eine blaue Plane. Insgesamt sind
774 Flüchtlinge an Bord, die meisten aus Afrika, erstaunlich viele Familien, 74 Jugendliche ohne
Eltern. Die Luft ist schwül, speziell unter den weissen Anzügen, die Politiker fluchen. Sie
wissen nicht genau, wie sie sich verhalten sollen, nur Chaouki ist in seinem Element. Im
Unterschied zu den anderen, die eng beieinander stehen bleiben, schüttelt er Hände, spricht
Englisch, Französisch und Arabisch, macht sich Notizen, so wie in den Lagern in Rom, so wie auf
Lampedusa, so wie fast jeden Tag seit Monaten. «Warum haben Sie sich auf die Reise gemacht?»,
fragt er einen Syrer, der mit seiner Frau und fünf Kindern unterwegs war, als sein Boot kenterte.
«Entweder wir sterben zu Hause oder auf der Überfahrt», antwortet der Mann, was mache das für
einen Unterschied. «Was erwarten Sie sich von Italien?», fragt er einen Jugendlichen. «Ein Land
ohne Bomben.» So geht das weiter, bis die San Giusto am frühen Nachmittag den Hafen von Reggio
Calabria erreicht, wo Polizisten auf die Migranten warten, Routineangelegenheit an Europas
Küsten. Sie stellen sich in Reihen auf, Jugendliche da, Familien dort. Es sind dieselben
Gurtbänder wie an den Flughäfen, wo Menschen geordnet Schlange stehen auf ihrem Weg zu
Geschäftsterminen oder in die Flitterwochen, aber dieser Hafen hier hat damit nichts zu tun, es
ist dessen Antipode.
«Wer keinen Pass hat und sich weigert, Fingerabdrücke zu hinterlassen, kann trotzdem passieren –
was sollen wir denn tun?», sagt ein Polizist. Sie hätten keine Zeit, jeden Einzelnen zu
überprüfen, die nächste Schiffsladung kommt in wenigen Stunden. «Und wenn ich ehrlich bin», sagt
er noch, «dann würde ich als Flüchtling auch nichts unterschreiben und Italien so schnell wie
möglich verlassen.» Italiens Asylwesen wird immer wieder kritisiert, die Grenzkontrolle sei zu
nachlässig, Akten würden verschwinden, der Informationsaustausch (Eurodac) gestalte sich
schwierig, heisst es gerade auch von Schweizer Behörden, die acht von zehn Flüchtlingen, die über
Italien nach Chiasso kommen, wieder zurückschicken – was gemäss Dubliner Übereinkommen auch
rechtmässig ist. Doch die Bedingungen in Italien sind derart prekär, dass nicht einmal die
Grundversorgung gewährleistet ist. «Was wir hier sehen, passiert in Italien jeden Tag an mehreren
Orten rund um die Uhr», sagt Chaouki und zeigt auf die Menschen in löchrigen T-Shirts, die später
in Busse verfrachtet werden und irgendwann auf den Strassen landen. «Manchmal muss man Dinge mit
eigenen Augen sehen, um das ganze Chaos zu verstehen», sagt er.
Hochzeitsreise nach Paris
Khalid war neun Jahre alt, als er nach Italien kam, ein schmächtiger Junge, der stark an Asthma
litt. Man brachte ihn in eine Klinik in der Nähe des Skiortes Cortina d’Ampezzo, die christliche
Nonnen leiteten. Dort hatte er ein religiöses Erwachen, so nennt er es heute, er fing an, fünfmal
am Tag zu Allah zu beten auf einem kleinen Teppich unter den Jesuskreuzen an der Wand. 2001 war
er einer der Gründer der Jungen Muslime Italiens, «er hat früh gelernt, sich zu behaupten», sagt
seine Frau Khalida, die ebenfalls aus Marokko stammt und gemeinsam mit ihrem Mann 2007 die
italienische Staatsbürgerschaft erhielt. «Früher hatten wir dauernd Angst, Italien verlassen zu
müssen. Auf unserer Hochzeitsreise wollten wir nach Paris, da hatten wir noch keine EU-Pässe, und
wir wurden an der Grenze zurückgehalten»; auch das habe ihn zu dem gemacht, was er heute sei,
erzählt Khalida über ihren Mann. «Er kam von ganz unten, und heute ist er im Parlament: Das ist
sein Bild von Europa, dafür kämpft er.» Khalida studierte Pädagogik und arbeitet heute nachts in
einem Migrantenheim für Kinder. Sie trägt das traditionelle Kopftuch, ihre Lippen sind
geschminkt. «Wir waren über- glücklich, als er ins Parlament gewählt wurde, der erste Politiker
Italiens aus Marokko, der erste Muslim, aber wir wussten auch, dass sich unser Leben verändern
wird.» Die Presse fiel über sie her, und wenn ihr Mann wieder mal in einer Talkshow antritt, wie
jüngst gegen Matteo Salvini von der Lega Nord, der ihm zurief, er solle doch nach Syrien, in
Italien habe er nichts verloren, dann sei in den sozialen Medien die Hölle los. «Das Land muss
sich in Zukunft noch mehr öffnen. Ich hoffe es auch für unsere Kinder», sagt Khalida. Manchmal,
wenn alles zu viel werde, wenn ihr Mann Khalid dauernd am Handy hänge und er zwischen zwei
Gutenachtgeschichten twittere und Sky-TV ein Interview verspreche, «dann verstecke ich alle seine
Geräte, seine Telefone und Tablets, weil er sonst nie aufhört».
Stundenlohn 3 Euro
Wieder auf der Strasse. Eine neue Woche, eine neue Expedition Chaoukis. Nachdem er die
Flüchtlingslager abgeklappert hat, auf den Schiffen war und in den Aussenquartieren, macht er
sich auf, um sich die Arbeitsbedingungen genauer anzuse- hen von denen, die in Italien bleiben.
Chaouki rast mit seinem Auto nach Sabaudia, 90 Kilometer ausserhalb Roms, dafür braucht er eine
gute halbe Stunde. Jemand sagte ihm, dass es indische Sikhs gebe, die gehalten würden wie
Sklaven. Das Amphetamin und Opium, die einige benötigten, um die Müdigkeit und die Strapazen der
Feldarbeit auszuhalten, bekämen sie gleich von ihren Arbeitgebern geliefert. Chaouki hat
daraufhin seine Anwälte informiert, ein paar Journalisten angerufen, und schon ist er unterwegs
in dieser ländlichen Gegend, wo heute über 8000 landwirtschaftliche Unternehmen ihr Gemüse und
ihre Früchte anbauen, die auch in der Schweiz auf dem Teller landen, aber das nur so nebenbei.
«Die meisten der Arbeiter auf dem Feld sind illegal hier», sagt Marco Omizzolo, ein Mann, der die
Gegend gut kennt; er war es, der Chaouki kontaktierte. «Sie kamen vor Jahren nach Italien und
sind einfach geblieben.» Menschen aus Bangladesh und Indien, erstaunlich viele Sikhs, sagt
Omizzolo, «stolze, in sich gekehrte Männer. Man muss sie gut kennen, damit sie erzählen, welche
Substanzen sie einnehmen, um so eine Zucchini-Ernte zu ertragen.» In einem nahen Sikh-Tempel
trifft Chaouki auf Gurvinder Singh, einen Bauern aus Punjab, der älter wirkt als seine 28 Jahre.
Singh kam 2011 nach Italien mit einem Arbeitsvisum für neun Monate, das längst abgelaufen ist.
«Wir werden gezwungen, 13 Stunden am Tag zu arbeiten, sieben Tage die Woche», erzählt er nach
einer Weile, dann verstummt er wieder, was Chaouki kaum aushält.
«Der Stundenlohn beträgt 3 Euro», fährt der junge Bauer aus Indien endlich fort, ein kräftiger
Mann, mehr als einen Kopf grösser als Chaouki. Er arbeite für einen Gemüsebetrieb, sein Chef, ein
Italiener, schulde ihm 6000 Euro, behauptet Singh, die Arbeit für sechs Monate. «Wenn wir ihn
darauf ansprechen, droht er damit, das Geld für immer zu behalten.» Chaouki, der so viele
Geschichten gesammelt hat über die Flüchtlinge und deren Blick auf sein Italien, wirkt
schockiert. «3 Euro in der Stunde?» «Ja», antwortet Singh, «ich fühle mich betrogen und
vergewaltigt.» Chaouki greift zum Telefon, benachrichtigt Politiker, noch mehr Journalisten, dem
leisen Singh, der so ungern über sich spricht, wird der ganze Rummel unheimlich, aber da ist
Chaouki schon nicht mehr zu stoppen. Er steigt ins Auto, wütend fährt er zu Ortoverde, einem
Gemüse- und Früchteproduzenten, der 80 Prozent seiner Ernte nach Deutschland, Österreich, auch in
die Schweiz exportiert, vor allem Karotten, Kraut und Kohlrabi. Er hat keinen Plan, als er den
Besitzer, einen Herrn namens Sergio Filosa, mit den Vorwürfen konfrontiert, wie er sich dabei
fühle, seinen Angestellten 3 Euro zu bezahlen, worauf ihn Filosa von seinem Grundstück jagt. «Das
ist moderne Sklaverei, einen Katzensprung von Rom entfernt», wird Chaouki später in die
Fernsehkameras sagen, die er selber bestellt hat. Auch so kommt man in die Schlagzeilen. Nicht
alle seiner Parteimitglieder mögen Chaoukis Auftritte, er sei zu jung, zu unerfahren, er mache es
sich zu leicht, weil er Probleme zwar anspreche, sie aber nicht löse. Chaouki kennt die Vorwürfe
aus den eigenen Reihen, doch sie lassen ihn kalt. «Die Linke in ganz Europa leidet unter
Komplexen. Aus lauter Angst, es sich mit jemandem zu verscherzen, haben sie vergessen zu handeln.
Und was ist passiert? Sie haben das Feld der Lega Nord überlassen, die im Fernsehen sagen darf,
was sie will.»
Dinner im Weissen Haus
In den Wintermonaten November, Dezember verschwinden die Bootsflüchtlinge aus den Medien, obwohl
die Zahlen alarmierend sind. Es sind zwar weniger als im Sommer, doch im Vergleich zum Vorjahr
hat sich die Zahl verzehnfacht. Dann folgt der Terrorakt auf die Zeichner von «Charlie Hebdo» in
Paris, der Anschlag in Kopenhagen. Barack Obama und sein Aussenminister John Kerry organisieren
in Washington eine Konferenz zur Terrorbekämpfung, und sie laden nebst Staatschefs auch wichtige
Vermittler ein, Brückenköpfe aus Europa. Menschen, die beide Seiten kennen, keine Falken, eher
Tauben, darunter den Bürgermeister Rotterdams, Ahmed Aboutaleb, und den 32-jährigen Kahlid
Chaouki, den rastlosen Journalisten, der das Italien der Migranten so gut kennt wie kaum ein
anderer. Er gelte als Stimme des neuen Italien, so stellt er sich vor und spricht in der Rede von
seinen Plänen, ein neues Davos zu organisieren, aber nicht für die Grossen und Mächtigen, sondern
für den arabischen Raum, speziell für die Jugend, jene Menschen, die illegal nach Europa kommen
wollen. «Man muss ihnen zuhören, auf ihre Bedürfnisse eingehen», sagt er, nur so könne man sie
von der Reise über das Mittelmeer abhalten.
Am Abend isst er im Weissen Haus, wo ihn viele für einen Praktikanten halten, das erzählt Chaouki
am nächsten Tag in einer Filiale von Subway in der Nähe des Aussenministeriums und lacht, während
er an einem Roastbeefsandwich kaut und über sein weisses iPhone fegt. «Die italienische
Nachrichtenagentur braucht ein paar Zitate», sagt er mit vollem Mund, aus den Boxen an der Decke
singt Taylor Swift. Es ist Mitte Februar, in Washington tobt ein Schneesturm, Chaouki steht
eingehüllt in seinen Mantel am Strassenrand. «Es wird wieder zu Tragödien auf dem Meer kommen,
die Lage in Libyen und in Syrien ist ausser Kontrolle.» Er sei mit den Leuten vor Ort in Kontakt.
«Die warten nur, bis es wieder etwas wärmer wird und das Meer sich beruhigt.» Was kann man tun,
um die Katastrophe zu verhindern? «Wir müssen die Operation Mare Nostrum wieder ins Leben rufen,
es ist unsere Pflicht, Flüchtlinge in Seenot vor dem Ertrinken zu retten, das Meer ist längst ein
Friedhof. Gleich- zeitig braucht es Auffanglager der EU in Afrika. Die Flüchtlinge sollen Asyl
beantragen können, bevor sie sich auf die Reise machen. Es bräuchte ein Quotensystem, damit sie
gerecht unter den Ländern Europas verteilt werden können, das Dubliner Übereinkommen taugt
nichts, zu viel lastet auf den Schultern Italiens.» All das sagt Chaouki, während wir die Strasse
überqueren zu Obamas Konferenz.
800 Tote? Ja, 800.
Zwei Monate später, in der Nacht vom 18. auf den 19. April, kentert ein völlig überladener
Fischkutter rund 200 Kilometer von Lampedusa entfernt. 800 Menschen sterben. Die Betroffenheit
ist gross, aber es gibt keine Demonstrationen in europäischen Innenstädten, ein paar Kerzen
vielleicht, aber keine Lichterketten, keine Schweigeminuten wie nach dem Attentat in Paris. Es
sind ja auch nicht unsere Toten, die auf dem Meeresgrund liegen, nachdem sie um Hilfe schrien,
was tönte, als wären es Möwen. Vier Tage später treffen sich Europas Staats und Regierungschefs
zu einem Sondergipfel in Brüssel. Merkel sagt, sie sei «erschüttert», im Oktober 2013, beim
ersten Unglück, war sie noch «tief bestürzt». David Cameron sagt nicht viel, denn er ist im
Wahlkampfmodus und wägt jedes seiner Worte ab. Papst Franziskus betet, spricht später von «tiefem
Schmerz» und hat Tränen in den Augen, während Tony Abbott, der Regierungschef Australiens, den
Europäern empfiehlt, die Grenzen endlich dichtzumachen und das Meer zu sperren, so wie er das
tue. «Es braucht europäische Asylbüros in afrikanischen Ländern», fordert Italiens Regierungschef
Matteo Renzi, es sind Chaoukis Worte; sowieso sind sich plötzlich alle einig, Mare Nostrum sei
richtig gewesen. Der deutsche Innenminister Thomas de Maizière stand vor einem Jahr noch auf der
Brem- se und fand alles zu teuer, jetzt sagt er: «Seenotrettung ist das Erste, Wichtigste und
Dringlichste, was unverzüglich beginnen muss.» Also verdreifachen sie das Budget – das zwei Jahre
zuvor schon einmal so hoch war, dann aber um zwei Drittel gekürzt wurde –, etwas mussten sie ja
tun; allerdings sind in der Zwischenzeit 5000 Menschen ertrunken. Es gibt keine Logik in der
Asylpolitik Europas, es gibt nur kopfloses Agieren und ein bisschen Betroffenheit. Was fühlen
Sie, wenn Sie von Ihrem Büro hinaus aufs Meer schauen, Frau Nicolini? Giusi Nicolini, die
Bürgermeisterin Lampedusas, sagt: «Trauer. Ich denke an die Tausende von Menschen am Meeresgrund,
die nie ein Begräbnis bekommen werden und über die niemand spricht. Ich denke an die 366 Särge
vor 19 Mona- ten im Hangar meiner Insel. Es waren nicht genug, um die europäischen Politiker
wachzurütteln. » Ein paar Tage vor der Tragödie fuhr Khalid Chaouki nach Catania, um ein
Flüchtlingsheim zu inspizieren. Er fuhr ohne Anmeldung, machte Fotos, tat, was er immer tut: Er
sprach mit den Menschen und versuchte, ihre Lage zu verbessern, sei es auch nur, die Ration an
warmem Wasser zu erhöhen. Bei den Sikhs in Sabaudia hat er auch erreicht, dass die Gewerkschaften
zu intervenieren begannen und höhere Stundenlöhne fordern. Es sind nur Tropfen im Meer, aber
immerhin. Er fuhr weiter nach Pisa an eine Konferenz über Migration und war schon auf der
Rückfahrt nach Hause, als ihn die Nachricht erreichte. Er rief das Innenministerium an, um die
Anzahl der Toten zu verifizieren. 800? Ja, 800. Dann schrieb er seiner Frau, wie er sich fühle,
und stellte sein Telefon für wenige Minuten auf lautlos.
© von Sacha Batthyany und Nicola Scevola
Passion & prejudice: the Loving family
for Casa Vogue
Richard e Mildred Loving non avevano intenzione di diventare paladini dei diritti civili in America. Volevano solo vivere nella loro Virginia natale e crescere i figli in pace. Ma quando, nell’estate del 1958, lo sceriffo della contea di Caroline irruppe in casa loro nel mezzo della notte per arrestarli con l’accusa di “incrocio razziale”, i due sposi furono costretti a chiedere aiuto. Richard è bianco e Mildred è parte nera e parte nativa americana. E nella Virginia degli anni Cinquanta il matrimonio interraziale è considerato un grave reato. Central Point, il paese dove vive la coppia, è povero ma ben integrato. Richard fa il muratore e da sempre è abituato a lavorare con afroamericani. E’ appassionato di gare di dragster e ha una macchina truccata con cui corre insieme a due amici neri. Uno di questi ha una sorella, Mildred, e una sera la presenta a Richard. I due si piacciono, s’innamorano e decidono di sposarsi senza troppo pensare alle conseguenze del loro gesto, che nel giro di poche settimane li porta dritti in galera. Dopo qualche notte in prigione, i Loving sono scarcerati, ma il giudice li obbliga all’esilio. La coppia si trasferisce controvoglia a Washington, D.C. dove il loro matrimonio è considerato legale, ma quando torna in Virginia per visitare le famiglie è arrestata di nuovo. La battaglia legale che scaturisce dura nove anni e segna una tappa fondamentale nel movimento per l’affermazione dei diritti civili.
Contrariamente ad altri casi, in cui i media sono usati per influenzare l’opinione pubblica ed esercitare pressione indiretta sui giudici, durante l’intero processo i Loving preferiscono mantenere un profilo basso, rilasciando poche interviste ed evitando qualsiasi esposizione inutile. E il pubblico reagisce dimenticando presto la loro storia. “Non volevano alcuna pubblicità”, ricorda Philip Hirschkop, avvocato che allora difese la coppia davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti. “Un po’ per evitare di diventare bersaglio degli estremisti del Ku Klux Klan, ma soprattutto perché tenevano alla loro privacy. Erano persone timide e riservate”. L’unico giornale a cui la coppia concede accesso è Life magazine, che manda il fotografo sudafricano Grey Villet a casa loro per due settimane. I Loving, però, chiedono al magazine di dare alla storia uno spazio ridotto. Pur essendo famoso per i suoi lunghi reportage fotografici, il giornale accetta, finendo col pubblicare solo poche pagine e selezionando le foto più neutre fra quelle scattate da Villet. Il fotografo è famoso per la sua capacità di svelare la natura intima dei soggetti ritratti, mettendoli a proprio agio come se le sue lenti fossero invisibili. Ha coniato anche un termine, psychograph, per descrivere le immagini più riuscite, che rivelavano la psiche di una persona attraverso gesti spontanei. Durante il suo soggiorno con i Loving, Villet scatta migliaia immagini, usando spesso lenti lunghe per essere meno intrusivo. E fra le circa cento che offre al giornale, ci sono molti scatti carichi di emozioni. Durante il processo, il procuratore dello Stato della Virginia sostiene che i figli nati da matrimoni interraziali sono “vittime e martiri dei loro genitori”. Ma le immagini di Villet dei tre bambini dei Loving che giocano e ridono comunicano esattamente il contrario. Peccato che queste non siano viste da nessuno. Le immagini pubblicate, infatti, sono fredde: niente lacrime, niente baci, nessuna intimità. I coniugi non sembrano neanche sfiorarsi e sono sempre ritratti insieme ad altri.
“Le foto scelte da Life non svelano il motivo reale che spinse queste due persone a lottare in corte per tornare a vivere da marito e moglie nella loro terra natale”, dice Erin Barnett, curatrice della mostra organizzata lo scorso anno dall’International Center of Photography di New York con le immagini scartate da Life, che Casa Vogue pubblica in queste pagine. “Richard e Mildred affrontarono questa battaglia in nome del profondo amore che li univa e le foto di Villet lo mostrano”. Il settimanale aveva spesso dedicato spazio a temi legati ai diritti civili, come le lotte contro la segregazione nelle scuole o contro la discriminazione sul lavoro. Ma questo caso era diverso: toccava un argomento ancora molto controverso nella società americana. Secondo un sondaggio dell’Istituto Gallup, nel 1958 solo il 4% degli americani approvava le unioni fra persone di razze diverse. “Life era un giornale popolare e probabilmente temeva di offendere la sensibilità dei lettori”, spiega Barnett. Il risultato è che gli scatti più evocativi e simbolici che raccontano la storia dei Loving finiscono nel dimenticatoio. Fino a quando, una film maker s’incuriosisce del caso dopo aver letto sui giornali il necrologio di Mildred Loving e decide di girare un documentario sulla storia. “Era il 2008 e un candidato alla presidenza come Barack Obama non sarebbe potuto neanche esistere senza i Loving”, ricorda Nancy Buirski, autore del documentario intitolato The Loving Story. “Il loro caso è alla base della libertà di matrimonio in questo paese ed è reso ancora attuale dal dibattito sul riconoscimento dei matrimoni gay”.
Per realizzare il film, Buirski ha bisogno d’immagini. I protagonisti sono entrambi
scomparsi: Richard in un incidente d’auto avvenuto pochi anni dopo la sentenza che nel ‘67
riconosce l’incostituzionalità della legge contro i matrimoni interraziali. E Mildred nel 2008,
stroncata da una polmonite all’età di 68 anni, mentre viveva ancora nella casa di Central Point
in cui è ritratta nelle foto. L’unica superstite è Peggy Loving, la figlia dei coniugi. Che in un
cassetto conserva una settantina di foto dei genitori, scattate nel 1965 quando la famiglia aveva
ottenuto un permesso temporaneo di tornare a vivere nella loro casa in Virginia in attesa di
giudizio. “Erano le foto che Life aveva scartato e Grey aveva regalato ai Loving”, dice Barbara
Villet, giornalista e vedova del fotografo scomparso nel 2000. “Era rimasto toccato dal lato
umano della vicenda, dalla storia d’amore fra Richard, Mildred e la loro famiglia”. Le immagini
hanno dato a Buirski l’opportunità di raccontare in video questa storia praticamente dimenticata
dal pubblico americano. E di riesumare le foto inedite di Villet, che andranno nuovamente in
mostra a New Orleans il giugno prossimo. “I Loving non volevano cambiare il mondo, ma solo
tornare a casa loro”, dice Buirski. “Erano due persone umili senza ambizioni politiche. Ma la
loro storia è importante proprio perché dimostra che chiunque può fare la differenza”.
© Nicola Scevola
Ganga river
for L'Uomo Vogue
Come le migliaia di fedeli indù che si recano in pellegrinaggio a Varanasi, ogni giorno Veer Bhadra Mishra prega rivolto al Gange e beve le sue acque marroni. Mishra è la guida spirituale di uno dei templi più importanti della città e non può sottrarsi al dovere di venerare il fiume più sacro dell’India. Allo stesso tempo, però, questo 72enne dalla folta chioma argentata, è anche un ingegnere idraulico. Ed è ben consapevole delle malattie che le acque inquinate del fiume possono causare. Ogni giorno centinaia di cadaveri sono cremati sulle rive del Gange. Il fiume è costellato da rifiuti e, a volte, perfino dai cadaveri di fedeli troppo poveri per permettersi la cremazione. Lungo le rive di Varanasi, l’acqua è praticamente settica, cioè contiene pochissimo ossigeno. Ma è zeppa di batteri fecali: circa un milione di volte oltre lo standard di una zona balneabile. “La mia parte razionale riconosce che quest’acqua è pericolosa”, ammette Mishra. “Ma il cuore mi spinge a continuare a venerarla”.
Per risolvere il problema, trent’anni fa Mishra ha fondato la Swatcha Ganga Abhiyan (SGA,
http://swatchaganga.com), associazione che lavora per monitorare l’inquinamento del fiume. La
causa principale sono le fognature di Varanasi che scaricano direttamente nel fiume. Ma i
frequenti black out escludono la possibilità di costruire un impianto elettrico. Con l’aiuto
dell’università americana di Berkley, Mishra ha disegnato quindi un sistema di canali a
precipitazione per deviare le acque. E un impianto per depurarle che sfrutta i batteri contenuti
in alghe naturali. L’impianto prevede la creazione di grandi vasche di alghe dove l’acqua viene
lasciata a decantare al sole. Gli scarti del processo possono poi essere riutilizzati come
concimi. Nel 2008 il progetto è stato approvato dal governo indiano e il primo impianto pilota
dovrebbe essere costruito entro quest’anno. Ma i tempi della burocrazia indiana sono lunghi e SGA
sta ancora aspettando i soldi. Nel frattempo, Mishra si dedica alla sensibilizzazione
dell’opinione pubblica. La credenza dei fedeli, infatti, rende difficile anche il riconoscimento
dell’esistenza del problema. “Il Gange è la dea madre”, sottolinea Mishra. “Non possiamo dire
alla gente che è inquinato, dobbiamo dire che è malato”.
© Nicola Scevola
NYC Parks
for IoDonna
“Dove andranno d’inverno le anatre di Central Park?” si chiedeva il giovane Holden nel romanzo di J. D. Saliger. La domanda pare escludere che New York offra alternative. Spesso, infatti, si tende a identificare con Central Park l’unico spazio verde della città, anche se i newyorkesi veri molte volte nel grande parco sono solo una minoranza. Specie d’estate, quando i suoi prati si riempiono di turisti in cerca di ristoro. Pur essendo famosa per la sua giungla di cemento e grattacieli, infatti, la metropoli dispone di un’invidiabile quantità di spazi verdi, popolata da decine di specie animali. A Prospect Park, eterno rivale di Central nel cuore di Brooklyn, ci sono talmente tante anatre che quest’estate il Comune ha dovuto abbatterne una parte per paura che intralciassero il traffico aereo. Poco distante, Fort Greene Park è un importante punto di appoggio nella rotta migratoria della farfalla monarca. Nei cieli di Pelham Bay Park, nel Bronx, si possono vedere volare i falchi pellegrini, mentre le paludi di Alley Pond Park sono abitate da tartarughe e rane. E a Forest Park, nel 2004, è stata avvistata una tigre. Ma quello era uno sbaglio. La belva era scappata da un circo e dopo qualche giorno la polizia è riuscita a rimetterla in gabbia. L’abbondanza di fauna è favorita dalla dimensione dei parchi. Al posto di frazionare gli spazi verdi, l’amministrazione ha sempre favorito la costruzione di grandi polmoni. Questo fin da quando, negli anni Trenta fu nominato a capo del Dipartimento dei Parchi di New York Robert Moses, una delle figure più potenti della storia della città. Convinto che la rinascita economica della città passasse attraverso il miglioramento delle condizioni di vita dei suoi abitanti, Moses estese le aree verdi a un totale di circa 790 chilometri quadrati. Facendo le dovute proporzioni, questo significa che New York ha più del doppio di verde rispetto a una città come Milano. Con i suoi 340 ettari, infatti, Central Park rappresenta solo il quinto parco in ordine di grandezza. E sono in molti a sostenere che non sia neanche il più riuscito. Gli stessi architetti che lo progettarono nel 1858, Olmsted e Vaux, pochi anni dopo disegnarono anche Prospect Park. Facendo tesoro dell’esperienza accumulata e approfittando di una topografia più malleabile, i due architetti realizzarono a Brooklyn quello che definirono il loro capolavoro, scatenando una rivalità ancora oggi irrisolta fra i frequentatori dei due parchi.
In realtà lo stile dei due giardini è molto simile, anche se quello di Brooklyn è spesso più fruibile perché meno affollato. “Lo preferisco per venire a correre perché è più tranquillo di Central Park”, dice Robert Kirkin, un corridore incontrato a Prospect Park che ha appena smesso di fare jogging spingendo un passeggino con dentro il figlio di tre anni. Durante la settimana, il parco è frequentato soprattutto da famiglie. Come quasi tutti gli spazi verdi della città, è molto sfruttato per fare sport e, da un paio d’anni, si è riempito di gente che corre trainando i pargoli in carrozzina. Ma la particolarità dei parchi newyorkesi sta nella varietà dei paesaggi offerti. A differenza di quello che si è portati a pensare, in fondo New York rimane una città d’acqua. E della sua abbondanza di coste e insenature si è approfittato per creare parchi diversi fra loro. Per godere dello spettacolo di un tramonto sull’Hudson, c’è il Riverside Park, che si estende lungo il fiume dalla 72esima strada fino alla 158esima. Ogni giorno, qui si trovano molti newyorkesi che, seduti sull’inseparabile sedia da campeggio, si godono il panorama del sole che scompare dietro le scogliere del New Jersey. “Mi basta per dimenticare tutto lo stress che questa città ti fa accumulare”, dice Christina Adams, un’infermiera che lavora alla vicina Columbia University. A Staten Island, molti scelgono di rilassarsi passeggiando sulla spiaggia del Wolfe’s Pond Park alla ricerca delle conchiglie Quahog, bivalve originario di queste coste, simile a una grossa vongola che produce perle violacee usate dai nativi americani per fabbricare gioielli. Spingendosi nel Bronx, i parchi della Grande Mela cambiano volto, mescolando paludi salmastre con foreste di querce e spiagge di sabbia. Invece che spingersi nel lontano New England, per ammirare lo spettacolo autunnale degli alberi cambiano colore prima di perdere le foglie, basta una visita all’orto botanico del quartiere. Qui, oltre al famoso giardino delle rose dedicato a Peggy Rockefeller, c’è una grande foresta di aceri e faggi che ogni anno, fra ottobre e novembre, si tinge di arancione, rosso e oro.
Pelham Bay è grande più di tre volte Central Park ed è il più esteso della città. Al suo
interno si trovano animali diversi come i procioni, cervi, gufi e granchi reali. Due campi da
golf, chilometri di sentieri equestri e la cosiddetta “riviera di New York”: una spiaggia
artificiale a forma di mezza luna creata da Moses unendo piccole isole con detriti e ricoprendo
il tutto con un milione di metri cubi di sabbia. Il risultato è una specie di Coney Island in
versione latinoamericana. La prevalenza d’ispanici che popolano il Bronx, infatti, si rispecchia
nell’atmosfera, con il ceviche che prende il posto degli hot dog, e i ritmi di mambo e merengue
che dominano rispetto a quelli dell’hip hop. E siccome i parchi della Grane Mela sono diventati
completamente sicuri, per aggiungere adrenalina all’esperienza, ad Alley Pond Park è stato aperto
un percorso di zip line, ponti tibetani e liane. Che ogni giorno attrae decine di dipendenti di
aziende costretti dai responsabili del personale a usare le corde alte per lavorare sulla fiducia
in sé stessi e la collaborazione. Alla domanda del giovane Holden su dove vanno le anatre quando
gela il lago di Central Park, verrebbe quindi da rispondere: “In tanti altri parchi della stessa
città”.
© Nicola Scevola
Nella pancia di Facebook
for IoDonna
Dall’esterno, l’archivio dei nostri ricordi sembra la sede di una polizia segreta. Il palazzo di cemento grigio ha muri spessi, finestre piccole e telecamere ad ogni angolo. L’unica scritta che l’identifica come il quartier generale di Facebook è piccola e defilata. Per entrare nella sede del social network è obbligatorio firmare un patto di riservatezza che copre qualsiasi informazione raccolta durante la visita. Stando al foglio, l’esistenza stessa dell’accordo deve rimanere segreta. Una volta dentro, però, l’atmosfera ricorda quella del dormitorio universitario da cui Facebook è partito solo sei anni fa. I cervelloni che gestiscono il flusso d’informazioni che 500 milioni di persone ogni giorno scaricano nei suoi server lavorano in un grande loft. C’è un monopattino a motore per terra e diverse biciclette appoggiate ai muri. Una lunga parete bianca coperta di scritte e scarabocchi. E un ragazzo con i capelli ossigenati che sta disegnando con pennarelli colorati una nuova frase. “Facebook fa schifo!*”, scrive ridendo insieme ad un collega. Poi aggiunge nell’angolo opposto della parete: “*Sto scherzando”. Da una stanza arrivano delle grida concitate: è in corso una sfida con i videogiochi. Al centro della grande sala, intanto, centinaia di persone si concentrano sui loro computer, sedute a scrivanie addossate le une alle altre.
Fra i 1400 dipendenti è difficile incontrarne uno coi capelli bianchi, e le t-shirt sono sicuramente più di moda delle giacche. D’altronde Mark Zuckerberg, il ventiseienne fondatore della compagnia oggi valutata circa 25 miliardi di dollari, non ha mai fatto segreto di preferire le ciabatte infradito alle scarpe coi lacci. Appesi alle pareti colorate ci sono decine di disegni ispirati ad un quadro di Magritte di un uomo con la bombetta e una mela che gli nasconde il viso. E’ uno dei poster preferiti di Zuckerberg, che l’ha disseminato in ufficio come monito contro il pericolo di trasformarsi in uomini d’affari senza scrupoli. Nel grande spazio comune non esistono uffici privati, ma solo sale riunioni con pareti trasparenti e nomi ispirati a gruppi musicali come Wham!, Inex e Mötley Crüe. “Facebook è basato sulla condivisione e questo si riflette anche nell’ambiente in cui lavoriamo”, spiega Elisabeth Lider, l’addetta stampa che ci guida nella visita. Neanche Zuckerberg ha una stanza personale. Passa la maggior parte del suo tempo muovendosi fra una riunione e l’altra. Ogni volta che il sito sta per lanciare una nuova funzione, si mette in piedi in mezzo alla sala e suona un grande gong di metallo. E quando è impegnato a programmare, siede a una scrivania in mezzo alle altre, identica a quelle dei suoi colleghi: stessa sedia e stesso schermo a 28 pollici collegato ad un computer portatile.
Nonostante il clima rilassato, il rumore di centinaia di dita che battono sulle tastiere riempie l’ufficio con un ronzio costante. C’è un via vai di ragazzi con i portatili sottobraccio che si spostano da una scrivania all’altra o fra le sale riunioni. A luglio il sito ha raggiunto i 500 milioni d’iscritti. Se, insieme al profilo sulla pagina internet, ad ogni utente fosse assegnata una cittadinanza virtuale, Facebook sarebbe la terza nazione più grande del mondo. “C’è un entusiasmo particolare fra chi lavora, ti senti parte di qualcosa di rivoluzionario”, dice Naomi Gleit, responsabile 27enne della divisione Crescita e Sviluppo. “Il traguardo dei 500 milioni è stato importante”, aggiunge indicando i cartelli sparsi per l’ufficio. Sono apparsi il giorno in cui è stata raggiunta la fatidica soglia e invitano i dipendenti a ringraziare gli utenti con messaggi da pubblicare sul sito. “Ora però siamo già concentrati ad arrivare a un miliardo”. Cinque anni fa Gleit è stata la prima donna assunta da Facebook, quando nella società erano solo 15 uomini e il sito contava un milione d’iscritti. “I miei colleghi erano un branco di nerd ventenni e passavano le notti in ufficio a risolvere rebus informatici mangiando pizza e bevendo Red Bull”.
Ora la proporzione fra i sessi si è riequilibrata e l’età media si avvicina più ai 30 anni,
ma l’entusiasmo per il lavoro sembra non essere cambiato. Una parte dei soffitti è lasciata
volutamente scoperta, con cavi e tubature che spuntano per enfatizzare il carattere di
laboratorio della sede. A dare il benvenuto ai visitatori davanti all’ingresso c’è un lungo
bancone che pare quello di un bar, ma ospita tecnici informatici pronti a risolvere i problemi
delle apparecchiature dei dipendenti. E l’ufficio spesso resta animato anche nelle ore piccole:
gli ingegneri hanno l’abitudine di organizzare hackathon notturni, riunioni informali per maghi
informatici che si ritrovano per sviluppare nuove idee. I partecipanti non sono ricompensati
dall’azienda per questi sforzi e nessuno ai vertici li spinge a farli. “Basta la prospettiva di
creare una funzione che potrebbe essere usata da mezzo miliardo di persone a motivarci”,
sottolinea Gleit, che attualmente si sta occupando anche di un’altra questione delicata: i
fantasmi degli utenti deceduti. A volte il server di Facebook consiglia automaticamente ai suoi
utenti di ricontattare un amico senza sapere che questo nel frattempo è mancato. Se nessuno
avverte l’azienda del decesso, infatti, il profilo della persona rimane attivo. Gleit sta
cercando una soluzione attraverso un software in grado di segnalare quando sul wall di un utente
appaiono scritte come “riposa in pace” o “non ti scorderò”. In modo tale che Facebook possa
verificare se l’utente è davvero deceduto. La questione sta generando un’ondata di cattiva
pubblicità. E’ solo un piccolo ostacolo per l’espansione di Facebook che serve, però, a
evidenziare la natura precaria del business dei social network. Non offrendo ancora un servizio
con un’utilità intrinseca, c’è chi è convinto che un errore di marketing o un cambio di moda
possa bastare per rendere obsoleto il sito in pochi mesi. “I miei genitori preferirebbero
trovassi un lavoro più stabile”, ammette Gleit. “Non capiscono che non sarò soddisfatta fino a
quando tutti non avranno Facebook nel mondo”.
© Nicola Scevola
Cheerleaders
for L'Uomo Vogue
Entrando nello spogliatoio delle cheerleaders della squadra di football dei Dallas Cowboys non si fatica a credere di essere nella sede delle ragazze pom pom più famose d’America. La stanza all’interno dello stadio è grande quanto quella dei giocatori di football, ma nell’aria aleggia un profumo di borotalco e lacca per capelli. Ognuna delle 34 cheerleader ha il suo spazio personale, con una panca ben rifinita dentro cui stivare il set di valigie rosa shocking in dotazione alla squadra e un grande specchio incorniciato da decine di lampadine. Il tutto sovrastato da una foto a dimensioni naturali della ragazza in divisa, con il suo nome sottolineato dalle stelline simbolo dei Dallas Cowboys. Con i loro stivali bianchi e le uniformi provocanti, le cheerleaders dei Dallas Cowboys, rappresentano in questo sport tutto americano quello che i New York Yankees sono nel baseball.Sono loro a essere chiamate regolarmente per intrattenere i soldati di stanza all’estero, a essere ritratte nei poster appesi agli armadietti dei liceali, a vantare il soprannome di America’s Sweethearts. Oltre ad essere atlete prestanti, capaci di ballare e fare acrobazie, le ragazze rappresentano agli occhi degli americani la quintessenza della provocazione sensuale. Tanto da aver ispirato uno dei più famosi film porno americani, Debbie Does Dallas.
In realtà, per far parte di questa squadra le ragazze devono aderire ad una rigorosa etichetta influenzata dai costumi puritani del Texas. Le regole della squadra, ad esempio, proibiscono loro di avere qualsiasi tipo di relazione con i giocatori di football e le scoraggiano ad uscire la sera, anche quando sono fuori servizio. Dalle loro biografie, la maggior parte delle ragazze risulta essere piuttosto conservatrice, la bibbia viene spesso menzionata fra le letture preferite. “Mantenere una certa reputazione è importante perché ci permette di distinguerci”, osserva Kaitlin Ilseng, studentessa di psicologia alla terza stagione con le Cheerleaders di Dallas. “Il pubblico ci rispetta per questo”, aggiunge raccogliendo i capelli biondi in preparazione per sessione di allenamento quotidiano. Quest’anno una sua compagna è stata espulsa dalla squadra perché si è ubriacata ed è stata coinvolta in un incidente in cui è intervenuta la polizia. Proprio questo cocktail di provocazione ed innocenza sembra essere alla base della fama che ogni anno porta centinaia di giovani a convergere su Dallas per partecipare alla selezione nella speranza di entrare nella squadra. “Diventare una cheerleaders dei Dallas Cowboys è il sogno della mia vita”, dice Olivia Stevanovski, diciannovenne di Detroit ammessa nella squadra da pochi mesi. Considerato che le America’s Sweethearts ricevono uno stipendio simbolico, si allenano incessantemente e sono tenute a comportarsi quasi come suore laiche, non è facile cogliere immediatamente la natura della sua aspirazione. Ma quando Stevanovski mi conduce sul campo da football dove si esibisce insieme alle compagne, tutto diventa più chiaro.
La casa dei Cowboys è uno stadio modernissimo da 110.000 posti, con il tetto retrattile, fontane d’acqua e opere d’arte gigantesche che decorano le pareti. “Esibirmi qui è l’emozione più grande della mia vita”, confessa giocando con la lampo della tuta blu che deve indossare per venire allo stadio ad allenarsi. Stevanoski è una delle otto matricole entrate in squadra lo scorso agosto. L’età delle sue compagne varia dai 18 ai 26 anni, con una sola cheerleader arrivata alla sesta stagione consecutiva. Il lavoro è molto impegnativo e la carriera media è di tre anni. “Per contratto dobbiamo anche studiare o lavorare”, dice Ilseng, che nel frattempo ha indossato la divisa da allenamento, composta da scarpe da ginnastica, pantaloni corti e un top blu molto discreto. “Spesso non abbiamo tempo per fare nient’altro”. Negli Stati Uniti sono circa 4 milioni le donne che fanno parte di una squadra di cheerleaders. Ogni franchigia che si rispetti ha la sua, ma le Dallas Cowboys continuano ad essere una categoria a parte. È la squadra di football della città texana ad aver inventato negli anni Settanta la formula che ha rivoluzionato questa attività: al posto delle ragazze che cantavano vestite con pantaloni e camice a maniche lunghe, reclutarono ballerine di bell’aspetto capaci di fare piroette e acrobazie. E le vestirono con uniformi attillate che lasciavano ben in vista gambe, ombelico e decolté. Il successo fu immediato, tanto che tutte le altre squadre imitarono le cheerleaders dei Dallas Cowboys, senza però riuscire ad eguagliarne il fascino e il sex appeal.
Ancora oggi la fama di questa squadra è tale da convincere le ragazze che ne fanno parte a lavorare sodo senza pretendere quasi nulla in cambio. Gli allenamenti si tengono tutto l’anno, cinque giorni a settimana, dalle 7 alle 11 di sera. La partecipazione è obbligatoria, pena l’espulsione dalla squadra, anche per chi non può ballare a causa di slogature o problemi muscolari. E la paga consiste in 150 dollari per ognuna delle dieci partite in cui è prevista la loro comparsa, oltre a qualche gettone di presenza per le partecipazioni a eventi pubblici. I soldi non sono certo lo stimolo che le convince ad andare avanti. “L’uniforme che vestono da loro uno status di celebrità”, osserva la coreografa della squadra Judy Trammel mentre dirige l’allenamento quotidiano in una palestra dello stadio. “Senza quella tornano ad essere ragazze della porta accanto”, aggiunge prima di sgridare un gruppo di ballerine che va leggermente fuori tempo. Il processo di selezione per diventare cheerleaders con i Dallas Cowboys è durissimo.
Ogni anno partecipano più di 600 ragazze, comprese quelle che fanno già parte della squadra.
Tutte devono dimostrare di meritare il proprio posto. Ci sono quattro audizioni,
un’interrogazione e un test scritto su materie che vanno dalla storia dei Dallas Cowboy alle
scienze alimentari. “Quando una televisione locale ha chiesto ad alcuni giocatori di fare il test
del nostro esame, è risultato che sarebbero stati quasi tutti bocciati”, sottolinea Ilseng con un
sorriso di soddisfazione. Chi passa la prima fase è invitata a partecipare ad un corso di due
mesi per la selezione finale, che prevede anche la somministrazione di un test antidroga. Le
lezioni sono filmate e usate come soggetto per un reality show. E servono ai responsabili della
squadra anche per valutare se la personalità delle aspiranti cheerleaders si adatta agli standard
morali richiesti. Alla fine, le candidate ammesse ricevono un manuale di regole e
raccomandazioni: come comportarsi quando firmano autografi, rilasciano interviste, appaiono in
pubblico e, in particolare, quando si esibiscono davanti alle truppe. Le ragazze sono consapevoli
di rappresentare miraggi provocanti agli occhi dei soldati, ma devono affrontare il loro
spettacolo pensando solo di “portare ai soldati un pezzo d’America per farli sentire a casa”,
come sottolinea la capogruppo della squadra. “Far parte delle Dallas Cowboys Cheerleaders è una
scuola di vita”, osserva Trammell. “E chi entra deve imparare a comportarsi da signora in
qualsiasi circostanza”, aggiunge prima di tornare a impartire ordini alle sue allieve.
© Nicola Scevola
ONU,operazione di facciata
for IoDonna
La statua della Madre con bambino di Giacomo Manzù giace abbandonata su un fianco in un angolo del giardino della sede delle Nazioni Unite a New York. Ha lo sguardo perso nelle acque dell’East River, come se stesse aspettando pazientemente di riprendere il suo posto, fra i ciliegi dove si ergeva fino a pochi mesi fa. La sua attesa, però, rischia di protrarsi per alcuni anni. Almeno fino al 2014, quando dovrebbero terminare i lavori di ristrutturazione del palazzo di Vetro cominciati a gennaio. Al posto della statua donata dal governo italiano, oggi sorgono le fondamenta di una struttura temporanea che ospiterà a rotazione i principali organi delle Nazioni Unite, sloggiati dalla loro sede con l’avanzare dei lavori. D’altronde il palazzo di Vetro aveva urgente bisogno di un lifting: piove dentro l'Assemblea generale, la struttura è ricolma d’amianto e il sistema di ventilazione è talmente vecchio che per abbassare la temperatura di qualche grado ci vogliono due giorni di lavoro. Il progetto originale, un classico della scuola modernista firmato da un pool d’architetti guidati da Wallace Harrison, Charles Le Corbusier e Oscar Niemeyer, con l’andare degli anni ha subito vari interventi che ne hanno alterato il carattere. “Il mio obiettivo è portare la struttura indietro nel tempo: voglio che il visitatore del 2014 abbia l’impressione di essere tornato al 1952”, dice Michael Adlerstein, architetto responsabile dei lavori ed esperto di siti storici cui fu affidata la ristrutturazione della Statua della Libertà. “Il palazzo rappresenta un simbolo importante, è uno dei pochi edifici del XX secolo conosciuto in tutto il mondo”. Nulla cambierà nell’assetto originale dell’Assemblea generale o del Consiglio di sicurezza, neanche le scomode sedie di pelle azzurra e rossa.
L’architetto ha intenzione di ripristinare il progetto nei minimi dettagli, compreso l’arredamento, l’illuminazione e perfino la segnaletica. “I cartelli erano scritti con un carattere speciale creato apposta per le Nazioni Unite che voglio riutilizzare”, sottolinea Adlerstein. Per raggiungere il suo obiettivo, il responsabile dei lavori dovrà mettere ordine al caos accumulato all’interno della sede di un’organizzazione nata nel dopoguerra con 57 membri e cresciuta fino a contarne 192. Nelle intenzioni dei padri del progetto, l’atrio principale avrebbe dovuto trasmettere un senso di trasparenza attraverso un grande spazio aperto che inizialmente si affacciava su una sala conferenze. Oggi quest’effetto è ridotto dalla presenza d’uffici ‘provvisori’mai smontati e stand espositivi spuntati come funghi. Su una parete si distingue una macchia d’umidità. All’interno dell’Assemblea le sedie sono coperte da un telo di plastica: la cupola, costruita perché l’ambasciatore americano sosteneva che quella forma avrebbe reso la sala più facilmente identificabile come parlamento, perde acqua quando piove. “Le condizioni della struttura sembrano una metafora delle Nazioni Unite”, dice un funzionario che ha chiesto di mantenere l’anonimato. “Ma l’organizzazione c’entra poco, perché è solo la somma delle volontà politiche di tutti i suoi membri”. Anche il tipico colore verde-azzurro della facciata del palazzo di Vetro è andato perduto. Dopo gli attacchi dell’11 settembre, all’interno è stata applicata una pellicola scura per dare elasticità alla superficie in caso d’esplosione.
Non tutto ciò che appare contribuire alla confusione architettonica del palazzo di Vetro
sarà però modificato. I diversi stili presenti sono anche frutto del compromesso raggiunto dagli
autori, che discussero accesamente fra loro. In una delle riunioni del gruppo, Le Corbusier
arrivò a strappare i disegni dei suoi colleghi. Alla fine, la sua idea fu adottata per la torre,
ma l’Assemblea generale fu costruita secondo la visione del collega brasiliano Niemeyer. “La
battaglia intellettuale che avvenne fra gli architetti rispecchia un po’ i confronti che
avvengono fra i membri dell’organizzazione”, fa notare Adlerstein. Ma la ristrutturazione non
sarà solo un’operazione di chirurgia estetica. Gli uffici della torre saranno sostituiti con
strutture aperte e meno gerarchiche. Adesso, il rango di un impiegato è simboleggiato dalle
dimensioni del suo ufficio e dalla presenza o meno di una finestra. Quelli nuovi, invece,
saranno grandi open-space comuni, più facili da illuminare e suddividere secondo le esigenze di
una struttura in continua evoluzione come le Nazioni Unite. Sarà eliminato l’amianto,
abbondantemente usato come isolante acustico e antincendio. E l’intero palazzo sarà reso più
eco-compatibile, con un risparmio energetico del 44%. “Installeremo turbine eoliche sul fiume e
cellule foto-voltaiche nei vetri della facciata. Vogliamo trasformare il palazzo in una vetrina
per le ultime novità della tecnologia verde”, spiega Adlerstein. Come spesso succede per i
progetti targati Onu, il costo della ristrutturazione è lievitato fino a raggiungere un totale di
1,9 miliardi di dollari, suddivisi fra i membri in base al loro contributo annuo. L’Italia
pagherà un conto da 95 milioni di dollari. Nonostante ciò, i lavori non prendono neanche in
considerazione l’eventualità di un’espansione del Consiglio di sicurezza, come chiesto più volte
dalla nostra delegazione. Adlerstein aveva chiesto se il progetto dovesse includere la
possibilità per un futuro ampliamento del tavolo del Consiglio. Ma la committenza ha scartato
l’idea. La politica – hanno fatto sapere dai piani alti del palazzo – non ha intenzione di
lasciarsi guidare dall’architettura.
© Nicola Scevola
Camorra wine
for Reuters
A new Italian white wine has become a symbol of the fight against organised crime, incurring the wrath of gangsters from Naples because it was produced from grapes grown on land confiscated from a Mafia godfather. Campo Libero, which means "Free Field", was presented this month as the first wine made in Lazio region with grapes grown on land taken from an important member of the Camorra -- as the Naples version of the Mafia is known. The lightly sparkling white wine is made from Trebbiano grapes cultivated by Il Gabbiano ("The Seagull"), a charity that employs people with troubled backgrounds, such as drug addicts. "The fact that we could turn a land bought with illegal earnings into something totally clean is the most important message we could send," said Dario Campagna, chairman of Il Gabbiano. He is modest about Campo Libero's bouquet, calling it a "farmer's wine", but hopes it will symbolise to consumers the value of fighting organised crime. Thanks to a law passed in 1996 by the Italian parliament, property belonging to convicted Mafiosi can be used for social purposes. In 2003, Il Gabbiano was given 10 hectares of land that had been abandoned for years. It once belonged to Francesco Schiavone, head of the most powerful and violent Camorrista family of Naples, whose empire spread from Naples to the farmland only 60 kilometres (37 miles) from Rome.
Roberto Saviano, a Camorra expert, wrote in his bestseller "Gomorra" that the Schiavone clan
ran illegal drugs and arms but also had semi-legal businesses such as cement production and
property developing, a shady empire worth some 5 billion euros ($6.7 billion). The land on which
Campo Libero grows was confiscated after Schiavone was convicted and sentenced to life
imprisonment. "When we got the land, it was like a rubbish dump. It took us three years and a lot
of work to change it," said Campagna. This year Il Gabbiano produced 10,000 bottles of wine, but
its success appears to have displeased the former owners. One night last September, just before
the first harvest was due, unidentified saboteurs destroyed half the vines. "We woke up and saw
we had lost around 50,000 kilos of grapes out of 140,000," said Campagna. "It was a real blow."
Police are investigating but Campagna says he knows who did it. "I think the Camorra are to
blame. They want the law letting their assets be confiscated to fail. It's in their interests for
this land to stay untouched. It's a sign of power." That is why Campagna and his workers did not
give up and last March replanted the vines from scratch. "It will take years for the vines to
grow again, but it's worth it," he said. "The more we fight for this wine, the better it will
taste in the end."
© Nicola Scevola
Urban Explorer
for D di Repubblica
“Il nostro motto è porta una torcia elettrica e lascia solo le tue impronte.” A cosa serva munirsi di una pila per esplorare in pieno giorno un palazzo abbandonato non mi è subito chiaro, ma obbedisco agli ordini della mia guida. Quando, però, mi trovo a calarmi in un tombino appena fuori da un manicomio di fine Ottocento costruito in mezzo alla campagna inglese, capisco tutto. O meglio, quasi. La vista di una volpe morta che galleggia in una pozza d’acqua formata all’imbocco del tunnel di servizio in cui mi sto per infilare, mi spinge a farmi altre domande. E mentre gattono nel buio pesto fra le ragnatele polverose e le tubature arrugginite che intasano i cunicoli sotterranei che si snodano sotto un ospedale abbandonato, qualcosa proprio non mi torna. Ma chi me l’ha fatto fare di infilarmi in questa situazione assurda per visitare un posto derelitto dove una volta si rinchiudevano i malati di mente, con la paura costante di venire scoperto dai guardiani? Eppure questo è il passatempo preferito dei miei accompagnatori, tre urban explorers che fanno parte di un movimento in grande crescita in Inghilterra. Più di quaranta siti internet e una rivista specializzata uscita quest’estate testimoniano la passione crescente degli inglesi per questa bizzarra attività. Guidati dalla smania di visitare luoghi abbandonati, queste specie di archeologi urbani hanno sviluppato una particolare forma mentis che gli fa interpretare qualsiasi cartello di ingresso vietato come un invito stimolante a vedere cosa ci sta dietro. Un rigido codice di condotta gli impedisce di forzare o rompere alcunché e, per accedere ai loro obiettivi, ai veri urban explorers è permesso solo di aguzzare l’ingegno e sporcarsi i vestiti. E in effetti, quando riemergiamo dai cunicoli ammuffiti per ritrovarci in un cortiletto interno del manicomio di Severelles, a un’ottantina di chilometri da Londra, ringrazio di aver indosso solo un paio di vecchi pantaloni e una felpa bucata.
Mentre mi spolvero i vestiti, la mia guida – un programmatore di computer di 42 anni di nome Simon Cornwell – cerca di rassicurarmi dicendomi che solitamente il guardiano si limita a fare la ronda intorno al perimetro della struttura. “Se stiamo dentro e non facciamo troppo rumore, nessuno dovrebbe accorgersi di nulla.” Poi, più a bassa voce, mi racconta come è cominciata la sua passione per questo bizzarro passatempo. “Inizialmente sono stato attratto dall’architettura di Cane Hill, un altro manicomio vittoriano ormai abbandonato da anni,” mi dice il ‘nonno degli Urban Explorer’, come viene soprannominato Simon nel suo giro. È stato uno dei primi a pubblicare su internet mappe e foto delle sue scoperte più di tre anni fa, e la sua mezza età gli conferisce una certa autorevolezza in un ambiente fatto prevalentemente di ventenni. “Una volta entrato, però, insieme al gusto infantile della scoperta fine a se stessa, mi sono lasciato conquistare dal fascino di visitare un luogo che in passato era stato abitato da centinaia di persone, e dove oggi non entra più nessuno.” Dopo aver scoperto che in Gran Bretagna esistono ancora decine di queste strutture abbandonate, Simon ha deciso di impegnarsi per vederne il più possibile, finendo con il diventare una specie d’esperto in materia.
Grazie ad un cambiamento nell’approccio con i malati psichiatrici e all’avvento di farmaci sedativi, oggi i vecchi manicomi inglesi sono stati perlopiù dimessi, trasformandosi in paradisi per questi archeologi del XXI secolo. Pur essendo fra le destinazioni più gettonate, però, i vecchi ospedali psichiatrici non sono i soli obiettivi degli urban explorers. Qualsiasi costruzione fatta dall’uomo è considerata interessante: dalle vecchie basi militari della guerra fredda ai siti industriali in disuso, dalle ville disabitate alle centrali elettriche dimesse. “La maggior parte di questi posti è destinata ad essere abbattuta o a crollare sotto il peso degli anni,” fa notare Simon con voce nostalgica. “Io cerco solo di andarci prima che scompaiano del tutto per fare delle foto. È il mio modo di preservare una memoria storica.” Dentro al manicomio di Severelles, lo spettacolo dell’architettura in decadimento è piuttosto affascinante, ma sono i residui dell’antica presenza dei pazienti a colpire l’immaginazione. Una valigia aperta su un letto. Una parete disegnata. Scarpe abbandonate. Frammenti di cartelle cliniche sparsi a terra. Ci sono lunghe fila di camere minuscole in cui erano rinchiusi i pazienti più gravi. Ogni porta ha una finestrella trasparente che permette di vedere all’interno. Su alcune c’è anche il nome del malato che ci viveva. “Non introdurre fogli di plastica: Vera tende ad ingerirli”, dice una delle targhette mezza sbiadita. L’ospedale è gigantesco. Una volta ospitava 2500 pazienti in reparti di massimo due piani, collegati da lunghi corridoi. La struttura vittoriana di mattoni rossi è malconcia, con alcune parti ridotte a grovigli di ceneri e metallo da un incendio scoppiato qualche anno fa.
Tom Nelson, un altro degli urban explorer venuto in gita a Severelles, vuole a tutti i costi raggiungere la torre dell’orologio in cima alla sede dell’amministrazione. Riusciamo ad accedere al piano terreno, ma le scale sono state sigillate. Giriamo per le stanze in cerca di un passaggio senza risultati. Proprio quando stiamo per rinunciare, Tom trova un vecchio montacarichi. “Da qua si può salire,” annuncia trionfante. Lo osservo scettico mentre si infila nella piccola tromba del montacarichi. Con i piedi puntati su una parete e la schiena su quella opposta, Tom riesce a issarsi fino al primo piano. A questo punto non mi rimane che imitarlo. Un pizzico di fascino per l’avventura e la voglia di giocare a guardia e ladri, in parte aiutano a spiegare la passione per questo genere di attività. Ma non è solo questo. “C’è una bellezza particolare nei palazzi in rovina,” spiega Tom, osservando il panorama dall’alto della torre, lo sguardo soddisfatto. “E come se avessero un’anima tangibile, qualcosa che manca alle costruzioni moderne.” Tutti e tre i miei accompagnatori sostengono che il fatto di essere costretti a violare la legge per entrare in questi posti sia solo uno svantaggio. Niente di cui andare fieri, ma un difetto a cui sono costretti a fare buon viso per poter alimentare la loro passione. “L’importante è rispettare il nostro motto e non rovinare nulla,” sottolinea Simon. Alla lunga, l’incontro con una guardia sembra inevitabile. Ma c’è stato un solo caso in Gran Bretagna di un ragazzo che ha passato una notte in cella. Il resto degli urban explorers se l’è sempre cavata con una ramanzina.
A volte, invece, proprio quando si sentono dei passi in lontananza e il cuore si ferma per la
paura, si finisce con l’imbattersi in altri esploratori. Urbex, come viene soprannominata questa
attività, sta diventando talmente popolare che capita di trovarsi in più squadre sullo stesso
sito. È così che Simon e Tom hanno incontrato il terzo accompagnatore, Mark, uno studente di
storia all’università di Cambridge. Non tutti gli appassionati, però, hanno lo stesso rispetto
per le costruzioni che esplorano. Ma danneggiando le proprietà altrui, si va contro alla natura
stessa di urbex. “Una parte del fascino di quest’attività sta nel vedere con i propri occhi
qualcosa che sta scomparendo, non nel contribuire a distruggerla,” spiega Mark. “Io amo il
silenzio assoluto dei luoghi abbandonati e il senso di disorientamento che possono dare. Mi fanno
sentire come un estraneo nel mio stesso paese.” Dopo aver trascorso quasi tre ore a scavalcar
cancelli ed esplorare reparti, si mette a piovere e la gita deve interrompersi. L’acqua rende
ancor più insicure le strutture diroccate e nessuno vuole correre dei rischi inutili. Non rimane
che infilarsi nuovamente nel tunnel per uscire senza dare nell’occhio. Una volta fuori, Mark
mette via pila e macchina fotografica e tira fuori dallo zaino l’immancabile ombrello inglese. Ha
l’aria soddisfatta e un po’ stralunata, come se fosse appena tornato da un viaggio in un mondo
lontano fatto di pareti scrostate e architetture decadenti. “Dopo tutto, è questione di
soddisfare le proprie curiosità,” dice quasi per giustificare la sua passione per le strutture
abbandonate. “E di non voler mai diventare del tutto adulti,” aggiunge Tom sorridendo.
© Nicola Scevola
Film noir
for D di Repubblica
Alla prima immagine proiettata sul grande schermo, la platea esplode in un boato di risate e grida di paura. Le bocche si spalancano e le mani corrono al viso. L’audio del film si mescola con i rumori della savana che si prepara per la notte e, a tratti, le immagini sono disturbate da un nugolo di moscerini attirati dal riverbero. Al posto di poltrone e aria condizionata, questo cinema ambulante che gira per i villaggi del Mozambico offre stuoie di pagliericcio e un vento caldo e secco. Ma nulla può rovinare la magia dello spettacolo proiettato sotto la volta immensa del cielo africano. Il pubblico segue le immagini con sguardo rapito. Molti non hanno mai visto neanche la televisione e alternano lo sguardo incredulo fra la grande tela bianca su cui si muovono le figure e il proiettore da cui queste sembrano uscire per incanto. Ma come è arrivato il cinematografo in questo villaggio sperduto dove non esiste luce elettrica o acqua corrente? È mattino tardi e il sole è quasi allo zenith quando nel villaggio di Punganhare, a pochi chilometri dal confine con la Tanzania, arrivano due fuoristrada sgangherati, ricoperti di autoadesivi colorati con la scritta “Cinemarena”. Gli abitanti riconoscono le macchine e i bambini le inseguono festeggiando fino a che si fermano nella piazza centrale. Dai 4x4 salta fuori una squadra di una decina di persone che si dirige dal capo villaggio. I soliti convenevoli di forma e poi un parlare fitto fitto. Dopo pochi minuti i nuovi arrivati si mettono all’opera. E in meno di un’ora, dove prima c’era solo uno spiazzo di polvere ora c’è tutto quello che occorre per una serata di cinema sotto le stelle. Schermo, proiettore, generatore e casse fanno capolino tra le capanne, trasportando improvvisamente questo villaggio remoto nella modernità dell’era digitale.
I bambini sono i primi a sedersi impazienti. Fingono di non sentire i richiami delle madri quando è l’ora di mangiare per non perdere i posti, e continuano a fissare lo schermo infuocato dagli ultimi raggi di sole. “Ma quello sono io!” esclama all’improvviso un bambino sgranando gli occhi e scappando davanti alla sua figura ripresa e proiettata sul grande schermo. Quando si fa sera, la tela bianca eretta nella piazza centrale si anima mostrando un breve video girato nel villaggio durante il giorno. La voce si è sparsa in fretta e sono accorsi a centinaia dai paesi limitrofi per assistere allo spettacolo. Con l’avanzare della notte, la pelle scura dei volti si confonde con il buio del cielo in una massa omogenea di colore che lascia intravedere solo i puntini bianchi di tanti occhi spalancati. Durante il giorno, mentre alcuni degli animatori di questo cinema itinerante si dedicavano a montare l’attrezzatura, altri hanno girato un breve instant-movie fra gli abitanti del villaggio. L’emozione davanti alle prime immagini proiettate è grandissima. C’è chi si sbellica dalle risate e chi rimane attonito. Oltre a mostrare film di tutti i generi, questo cinema ambulante sfrutta la grande potenzialità comunicativa delle immagini per aprire un dibattito su alcuni problemi che riguardano i villaggi da vicino. L’idea è di riprendere vari aspetti della vita quotidiana per divertire e, allo stesso tempo, parlare di questioni importanti. Come si conserva il cibo, dove si prende l’acqua o si buttano i rifiuti, come si cucina e quanto ci si lava – tutto è utile. “Ci siamo ispirati all’esperienza del cinema di strada,” dice Fabrizio Falcone, responsabile del progetto Cinemarena che, grazie alla sponsorizzazione della Cooperazione italiana, da anni fa arrivare il cinema negli angoli più remoti del Mozambico. “Portiamo l’emozione del grande schermo dove non c’è neanche la televisione. E sfruttando l’entusiasmo suscitato dall’avvenimento, approfittiamo per condurre una campagna di sensibilizzazione sui problemi vicini a questa gente.”
Prima di proiettare un film, oltre all’instant movie vengono, infatti, mostrati dei video educativi che parlano di AIDS o di colera. In Mozambico, come in molti altri paesi africani, queste malattie sono responsabili di vere e proprie stragi. Più che la pericolosità dei virus in sé, però, ciò che ingigantisce il problema fino a fargli assumere proporzioni drammatiche è la mancanza di informazione sulle malattie stesse. E così, prima di rilassarsi davanti ad una commedia africana o alle comiche di Stanlio&Ollio, gli spettatori sono invitati alla discussione da filmati educativi. I video sono sempre il più possibile vicini alla realtà, per permettere a chi li guarda di identificarsi con le situazioni rappresentate. Così in uno si racconta la storia di un minatore che è andato a lavorare lontano dalla famiglia e tornato a casa sparge inconsapevolmente il virus dell’AIDS, e in un'altra quella di un uomo che corteggia una prostituta per convincerla a fare l’amore senza usare il preservativo. “Tu sembri così sana,” le dice l’uomo tutto eccitato. “Perché vuoi farmi mettere tra carne e carne quell’orrendo affare di plastica. Sarebbe come mangiare la banana con la buccia.” Dopo la parte “impegnata”, arrivano i sogni e le emozioni delle grandi pellicole: soprattutto film africani, ma anche qualche classico del cinema europeo, che dà l’opportunità agli abitanti di Punganhare di confrontarsi con delle realtà a loro più o meno familiari. Così, se da un lato la gente si stupisce per le situazioni paradossali presentate dalla Pantera Rosa, dall’altro ritrova situazioni ben riconoscibili che aiutano ad avvicinare la realtà europea a quella africana. Durante la proiezione di Ladri di biciclette, ad esempio, gli spettatori si meravigliano e ridono nel vedere che, nella Roma degli anni ’50, anche le donne italiane erano costrette a fare la fila per prendere l’acqua alla fonte. Con le decine d’idiomi diversi che si parlano in tutto il Mozambico, la barriera linguistica può sembrare un ostacolo difficilmente sormontabile. I video educativi sono tradotti nel dialetto locale di Punganhare, ma i film vengono proiettati solo in portoghese. Poco importa, però, se non si capiscono le parole. L’atmosfera magica del cinema sembra riuscire a catturare ugualmente l’attenzione della platea, un po’ come accadeva da noi all’inizio del Novecento davanti alle immagini dei film muti. E quando lo spettacolo finisce, la gente va avanti a parlare dell’avvenimento per giorni, sia tornando a raccontare la scena di un film, che commentando i consigli pratici o i dilemmi posti dai cortometraggi educativi.
La capacità di incidere e comunicare delle immagini è enorme e, grazie alle tecnologie moderne, l’esperienza di portare avanti campagne di sensibilizzazione attraverso il cinema ambulante sta prendendo piede in varie parti del continente: in Kenya e Burkina Faso per i rifugiati, in Sud Africa, Zimbabwe, Namibia e Lesotho per la lotta all’AIDS, in Sierra Leone e Guinea Conakry per la sensibilizzazione sull’ambiente. Non tutte le associazioni che promuovono questo tipo di progetti sono necessariamente impegnati con programmi a scopo sociale. C’è anche chi, infatti, lo fa puramente per amore del cinema. “A noi interessa più che altro portare il cinema dove di solito non c’è,” dice Christian Lambert, fondatore di Cinema Numerique Ambulant, la più grande associazione che porta il grande schermo in giro per la savana africana. Fondata nel 2001 – lo stesso anno in cui il Cinemarena muoveva i primi passi in Mozambico – l’organizzazione è nata dalla passione e dalla creatività di un gruppo di film makers francesi e si concentra sui quattro paesi francofoni dell’africa occidentale: Benin, Mali, Niger e Burkina Faso. Lambert spiega che l’idea è nata dalla semplice frustrazione al pensiero che la maggior parte degli africani non avessero accesso alle decine di pellicole sull’Africa che venivano prodotte. “Anni fa, mentre giravo un film in Africa mi sono sorpreso a pensare che solo in pochissimi fra i diretti interessati avrebbero avuto l’opportunità di vedere come il loro continente viene rappresentato. E ho deciso di fare il possibile per cambiare questa realtà.” Oggi, grazie ad una rete composta da una serie di strutture indipendenti che girano nei quattro paesi, più di due milioni di africani sono stati raggiunti da questo cinema ambulante. L’idea è di creare dei circuiti che permettano di ripassare da ogni villaggio, per interessare gradualmente la gente al mondo del cinema. Per raccogliere i fondi necessari ad acquistare e mantenere il materiale necessario a mandare avanti il progetto, anche il Cinema Numerique Ambulant si presta, a volte, a servire da veicolo per mostrare, oltre a film africani, qualche video educativo. “E’ il modo migliore per rimediare degli sponsor, ma in realtà, quello che a noi interessa veramente è portare in giro cultura, proprio come nella tradizione degli artisti di strada. E proprio come questi facevano un tempo, in cambio dello spettacolo anche noi chiediamo agli abitanti del villaggio solo del cibo e l’ospitalità per la notte,” spiega Lambert.
A Punganhare lo spettacolo volge al termine. Quando anche i titoli di coda hanno finito di
scorrere e lo schermo ritorna ad essere solo un lenzuolo bianco che si staglia contro il cielo,
il pubblico comincia a disperdersi. Alcuni si riuniscono in capannelli per commentare concitati,
altri si ritirano silenziosi, quasi fossero ancora ipnotizzati dalle immagini. In breve, la
squadra di Cinemarena ha finito di smontare l’attrezzatura e tutti se ne vanno a dormire. Il
giorno dopo la sveglia è di buonora per affrontare quattro ore di pista massacrante e arrivare
alla prossima tappa del viaggio. Dopo aver rimontato l’attrezzatura in uno spiazzo appena fuori
dal nuovo villaggio, i tecnici si rilassano per qualche ora attendendo il calar del sole e
l’arrivo della gente. Al tramonto, però, solo poche decine di persone dall’aria preoccupata si
ritrovano sedute davanti allo schermo all’aperto. Mancano tutti i gli abitanti dei villaggi
limitrofi. Gira voce che qualcuno abbia avvistato un leone affamato, e la via del cinema per
stasera rimane bloccata.
© Nicola Scevola
Terror in Londonistan
for Il Foglio
Doveva essere un giorno di celebrazioni per essersi aggiudicati le Olimpiadi, invece si è trasformato in una mattina di esplosioni, sirene e lacrime. Meno di ventiquattr’ore dopo l’inaspettata decisione del Comitato Olimpico, Londra è stata scossa da un’ondata terroristica che ha cancellato in un attimo la gioia dei suoi abitanti, lasciando tutti ammutoliti ed increduli. Dopo le quattro esplosioni che si sono susseguite a pochi minuti di distanza nella mattinata di ieri, la città si è sentita improvvisamente vulnerabile. In pochi minuti le strade del centro si sono riempite di gente e il traffico è impazzito. Nella City, il cuore finanziario della capitale britannica, un esercito di businnessmen in giacca e cravatta si è trovato a brancolare confuso sotto la pioggerella rada. La polizia ha fatto evacuare tutti i palazzi nell’area fra Liverpool Street e Aldgate, le stazioni metropolitane fra le quali è esploso un treno, costringendo i lavoratori ad uscire dagli uffici. Agenti a cavallo cercavano di gestire la folla gridando ordini al megafono: “Non camminate in mezzo alla strada, state lontani dalle vetrine!” La gente si spostava confusa dal centro della strada ai marciapiedi senza sapere dove stare. Ogni tanto, dalla stazione della metropolitana di Liverpool Street usciva qualche persona annerita dal fumo e visibilmente scossa.
Dave Grant stava andando in ufficio in metropolitana quando il treno su cui viaggiava è stato investito da un’esplosione assordante. “Ho visto un bagliore accecante arrivare dai vagoni dietro e poi è diventato tutto buio,” ha detto Dave al Foglio. “Ho notato almeno un paio di persone che sanguinavano. Dopo circa dieci minuti sono arrivati i soccorsi e non ho più voluto guardare,” aggiungeva ancora tremante. “Il fumo rendeva difficile respirare, ma tutti sono rimasti calmi,” gli faceva eco Loyita Worley, che era anche lei sullo stesso treno. “La sola cosa che voglio ora è andare in ufficio per bere una tazza di te e cercare di capire quello che mi è accaduto.” Loyita non era la sola ad essere confusa. Tutte le persone riversate per le strade sembravano domandarsi cosa stesse succedendo alla loro città. Con il passare del tempo le notizie degli attentati nelle altre parti di Londra rimbalzavano da un passante all’altro e i volti della gente si facevano sempre più preoccupati. Diventava chiaro che, quello che inizialmente era parso un attentato isolato, era invece parte di un piano più articolato. Tutti cercavano di chiamare amici e parenti con i cellulari per rassicurarsi a vicenda ma le reti erano intasate. Volanti della polizia, ambulanze, camion dei pompieri, era tutto un urlare di sirene e lampeggianti blu che cercavano di farsi largo nelle vie intasate dal traffico.
Le autorità hanno tardano un po’ a bloccare il flusso di pendolari che cercavano di
raggiungere il centro di Londra, ma a circa un’ora dal primo attentato la rete di trasporti
pubblici veniva interamente bloccata contribuendo al caos generale. Alle fermate degli autobus la
gente aspettava con aria impotente. “Verso le 10 e mezza [dopo le esplosioni, ndr] ero alla
periferia di Londra dove mi è stato suggerito di prendere un autobus perché c’erano problemi alla
metropolitana,” si lamentava Ioannis Malliaris, uno psicologo greco che lavora a Maudsley
Hospital. “Se mi avessero almeno consigliato di non venire in centro adesso non mi troverei qui
bloccato.” I bar erano tutti stracolmi di gente incollata alla televisione o alla radio per
cercare di capire cosa stava succedendo. Quando a mezzogiorno Blair ha parlato alla nazione
dall’albergo in Scozia dove ospitava i leader dei G8, fra la folla è calato un silenzio totale.
Fra di loro c’era anche un ricercatore italiano che aveva visto da vicino uno degli incidenti.
“Sono uscito di casa e ho sentito un boato assordante,” raccontava Lorenzo Pia. “Mi sono girato e
ho visto un autobus completamente schiacciato. Era orribile, c’erano macchie di sangue anche
sulle pareti delle case di fianco.” In Trafalgar Square, la piazza dove solo poche ore prima si
era celebrata la vittoria per la candidatura alle Olimpiadi del 2012, l’atmosfera era
completamente cambiata. Alcuni turisti uscivano dalla National Gallery per paura di stare in
luoghi troppo affollati e degli operai smontavano un palco sistemato sotto l’obelisco
dell’Ammiraglio Nelson. “Amnesty International avrebbe dovuto celebrare qui una qualche
commemorazione,” spigava uno dei manovali. “Ma dopo quello che è successo è stato tutto
annullato.”
© Nicola Scevola
Gun culture
for L'Officiel
John Daughtery scruta l’orizzonte dall’ottica della sua carabina, appoggiato a un tavolo sistemato nel nulla della prateria del Sud Dakota. Di fianco a lui, il suo pick-up e una montagna di bossoli sparati ai “cagnolini della prateria”, sorta di scoiattoli che popolano le lande della Real America, l’America vera, come chiamano la regione bagnata dal fiume Missouri che va da Saint Louis al Montana. È la terra che custodisce il mito della frontiera, dove è più radicato il culto delle armi. Nonostante nella prateria si viva ancora con le porte aperte, qui l’arma è considerata indispensabile quanto il cellulare. John ha guidato 16 ore, macinando più di 1500 chilometri dal Texas natio solo per il gusto di sparare ai cagnolini della prateria che fanno capolino dalle loro tane. Quando li centra, alza un braccio in segno di vittoria senza curarsi di raccoglierli. «È troppo divertente», dice. «Per me è come giocare a calcio, a football o a golf». Da queste parti il fascino delle armi sconfina in una vera cultura. Le ultime statistiche indicano numeri impressionanti: quasi la metà di tutte le pistole e i fucili privati del mondo è posseduta da cittadini USA. E se è vero che la maggioranza degli appassionati sono uomini, anche le donne mostrano una certa inclinazione, con quattro armi su dieci in mano loro.
Persino nella liberalissima New York, che sulle armi vanta fra le leggi più restrittive dell’Unione, esiste un poligono riservato alle donne che viene spesso affittato per celebrare feste d’addio al nubilato. Se non hai precedenti penali, in America è più facile comprare un fucile d’assalto che un antidolorifico in farmacia. E anche all’indomani di stragi sanguinose come quella del liceo in Florida, si fatica a trovare esperti disposti ad ammettere l’esistenza di una connessione fra i frequenti massacri e l’abbondanza di armi. «Nel Duemila c’erano 250 milioni di armi nel Paese, ora sono oltre 300 milioni, più armi che abitanti», dice Sam Dotson, ex capo della polizia di Saint Louis, seconda città più violenta d’America con una media di 57,7 omicidi ogni 100mila abitanti. «Tuttavia è difficile dire se la violenza sia dovuta alla quantità di armi in circolazione o alla quantità di criminali in circolazione». Dal massacro di Sandy Hook del 2012, quando un assassino uccise a colpi di fucile 20 bambini e 6 adulti in una scuola del Connecticut, le stragi sono diventate più violente. Dal 2009, negli USA la media d’incidenti da arma da fuoco con oltre 4 morti e/o feriti è quasi uno al giorno. Ma i massacri peggiori sono avvenuti negli ultimi 5 anni: basta pensare ai più recenti, quello di Las Vegas che ha fatto 55 vittime e oltre 500 feriti e quello in Florida, dove sono morti una ventina di studenti. I criminologi si arrovellano per spiegare questa recrudescenza senza trovare risposte. Certo, la grande disponibilità di armi non aiuta. Ma allora perché non limitarla? Quando la politica si è attivata i risultati ci sono stati. Agli inizi del Novecento, il Tommy Gun, “il mitragliatore che fece ruggire gli anni venti” con il suo caricatore circolare, divenne il simbolo dei gangster americani. Fino a quando il presidente Roosevelt non firmò una legge che proibì la vendita di armi automatiche, fucili a canne mozze e silenziatori, bloccandone di fatto la diffusione. L’efficacia di questa norma è ancora evidente, visto che oggi negli Stati Uniti solo tre crimini ogni 1000 sono compiuti con armi automatiche. Quel che manca, quindi, non sono leggi efficaci ma la volontà politica e, ancor prima, culturale. Che è il motivo per il quale le stragi sono ormai considerate fatalità inevitabili, al pari di terremoti e tifoni. Da stranieri è difficile cogliere la logica di un simile ragionamento.
Ma considerare i fattori che hanno contribuito a formare questa mentalità, aiuta a contestualizzare la situazione. Per i primi 250 anni della loro storia, gli Stati Uniti furono un paese di agricoltori e pionieri con confini in espansione. Il lupo, dicevano gli yeoman, era sempre alla porta. Sotto forma dell’animale dal pelo grigio o dell’indigeno dalla pelle rossa che, per frenare l’invasione dell’uomo bianco, si vendicava sui coloni. In quest’ottica è facile comprendere dove inizia il rapporto intimo degli americani con le armi, che ancora oggi citano l’autodifesa come il motivo principale per possederne una. Esaurita la fase del wild west, questo strumento di difesa entra a far parte dell’immaginario collettivo attraverso lo sport più diffuso dell’epoca: la caccia. Prima dell’affermazione di baseball e football, la passione di sparare cervi e bisonti era un ingrediente imprescindibile della cultura popolare celebrata dall’industria dell’intrattenimento: al cinema, nei libri e in TV, il cowboy dal grilletto facile che ha il fucile per amico, era l’eroe dell’immaginario a stelle e strisce. Un tempo, inoltre, il possesso di fucili e pistole era un privilegio riservato all’uomo bianco. Questo contribuisce a farne un simbolo di potere e affermazione sociale. C’è un altro fattore importante: gli Stati Uniti nascono dalla ribellione al giogo dell’impero britannico, esperienza che instilla nel popolo una diffidenza atavica verso qualsiasi governo centrale.
Un sentimento che, durante la Rivoluzione, si cristallizza nell’idea che il possesso di armi
fra privati sia una garanzia contro la tirannia. Un principio sancito dal Secondo Emendamento
della Costituzione che prevede il diritto degli individui di armarsi. Su questo s’innesta
l’interesse economico della lobby del settore che nel 2017 ha fatturato quasi 100 miliardi di
dollari. Alle elezioni 2016, la National Rifle Association ha donato 53,4 milioni di dollari,
mobilitando i suoi 5 milioni d’iscritti per appoggiare i candidati più sensibili. «La NRA ha
un’enorme capacità di motivare la propria base», nota Robert Spitzer, criminologo dell’Università
di New York Cotland e autore di diversi libri sull’argomento. Al grido orgoglioso di slogan come
“non puoi prendere a pugni la dittatura”, la NRA sostiene che le recenti stragi di civili siano
il prezzo da pagare per garantire ai cittadini la libertà di reagire contro una possibile
involuzione antidemocratica dello stato. Tutto questo aiuta a spiegare la simbiosi tra gli
americani e le armi. Un rapporto nato dalla necessità di difendersi contro i pericoli della
frontiera che ancora permea la cultura popolare, tanto da considerare che il diritto di possedere
un’arma sia la norma e non l’eccezione. Un legame così radicato da far dichiarare a un
appassionato di caccia come John Daughtery, non a un fanatico guerrafondaio, che «le armi non
uccidono, è la gente che lo fa. Per questo la miglior difesa è armarsi e imparare a sparare.
Fateci caso: le tragedie peggiori succedono sempre nei luoghi in cui è vietato portare armi».
© Nicola Scevola